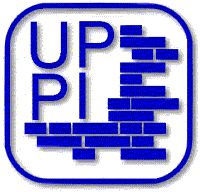Corte dei Conti, il report sullo stato di attuazione di Pnrr e Superbonus
- 14 gennaio 2025

La Corte dei Conti ha elaborato il report semestrale sul Pnrr: si procede a tappe forzate. Tutti i 39 traguardi europei previsti per il primo semestre 2024 sono stati raggiunti, portando l’avanzamento complessivo al 43 per cento, con un incremento di sei punti rispetto al semestre precedente.
Sul fronte delle procedure interne di monitoraggio nazionale, dice la Corte dei Conti, il progresso è ancora più marcato, con un tasso di completamento che sfiora l’88 per cento. Tra i successi concreti figurano la riduzione dei tempi medi per l’esecuzione di opere pubbliche (passati da 273 a 246 giorni) e un calo di oltre il 90 per cento dell’arretrato giudiziario presso Tar e Consiglio di Stato rispetto al 2019.
Il Superbonus 110% aveva promesso una rivoluzione green per il settore edilizio, e i numeri non mentono: 17,5 milioni di metri quadrati già efficientati contro i 17 milioni previsti. L’obiettivo finale di 35,8 milioni entro il 2025 sembra alla portata. Ma, dietro i traguardi raggiunti, si nasconde un costo altissimo per le casse pubbliche.
Il disagio abitativo e le politiche sulla casa
L’edilizia residenziale pubblica e quella sociale, che costituiscono il principale strumento in grado di incidere sul problema della tensione abitativa e del disagio soprattutto dei ceti più poveri, raccolgono nel PNRR risorse contenute, rientranti prevalentemente nel Piano innovativo per la qualità dell’abitare, cosiddetto PINQuA (2,8 miliardi), ai quali si aggiunge la dotazione del Piano Nazionale Complementare per la misura Sicuro, verde e sociale (2 miliardi).
Inoltre, tali misure puntano soprattutto alla riqualificazione e alla manutenzione, più che a un incremento dello stock mediante nuove costruzioni, non sfruttando appieno l’occasione del PNRR per aumentare gli sforzi di edificazione di nuovi alloggi.
Sotto il profilo attuativo si evidenziano ritardi per molti progetti, in particolare nei casi in cui la realizzazione risulta maggiormente complessa (ovvero, quando si tratta di opere pubbliche).
Prendendo a riferimento i progetti rientranti nel PINQuA, che rappresenta la misura del Piano più strettamente connessa alla questione abitativa, oltre un terzo di essi presenta dei ritardi rispetto alla rispettiva programmazione temporale. Inoltre, circa l’80 per cento di tali ritardi si concentra nelle fasi precedenti l’avvio dei lavori.
Gli interventi pubblici per mitigare le tensioni abitative, concentrati soprattutto sulla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), sono stati importanti nel dopoguerra, e fino agli anni Ottanta, mentre negli ultimi decenni si è osservato un sostanziale disinvestimento, che si è tradotto anche in un ridotto sforzo per la manutenzione dello stock esistente.
In generale, inoltre, le risorse destinate al sostegno delle famiglie meno abbienti per il diritto alla casa sono modeste.
Dall’analisi su un ampio campione di immobili pubblici adibiti ad abitazione (per oltre 750mila unità, dato reso disponibile dal MEF) si osserva come gli alloggi ERP siano caratterizzati da un’elevata età media e da tagli medio-grandi.
In particolare, oltre la metà degli immobili del campione risulta edificata prima del 1980, e la dimensione media è pari a 77 metri quadri. Questo comporta, unitamente alla ridotta manutenzione degli ultimi anni, una scarsa efficienza energetica, oltre ad altre problematiche legate alla vetustà degli alloggi, nonché una non piena rispondenza alle esigenze di una utenza sempre più composta da singoli o da famiglie piccole.
Dai dati si evince inoltre come gli alloggi si concentrino nelle zone a maggior grado di urbanizzazione, dove d’altronde la necessità è maggiore: nei centri urbani sono presenti mediamente 19,8 abitazioni di edilizia popolare per ogni mille cittadini residenti, mentre tale rapporto si attesta su valori decisamente inferiori, pari a meno della metà, nelle aree più periferiche.
I fabbisogni inevasi, come evidente in base alla dimensione delle graduatorie per l’accesso ad alloggi ERP, restano comunque rilevanti: secondo fonti ufficiali, le famiglie ancora in attesa di assegnazione di un alloggio di edilizia popolare erano quasi 320 mila nel 2016.
Un’analisi delle graduatorie dei principali centri urbani suggerisce inoltre che sia probabile che tale numero sia aumentato nel corso degli ultimi anni.
In estrema sintesi, la Corte dei Conti precisa che, nonostante gli interventi di riqualificazione, manutenzione ed efficientamento consentano di ampliare gli alloggi disponibili, opportunamente recuperando quelli sfitti perché difficilmente utilizzabili, si è forse persa un’occasione per aumentare gli sforzi di edificazione di nuovi alloggi.
In conclusione, per quanto sia apprezzabile che la questione abitativa sia rientrata, seppure con un ruolo non prioritario, nella programmazione del PNRR, è difficile pensare che questo possa rappresentare un’inversione di tendenza nei servizi offerti ai cittadini, a meno che ulteriori programmi in questo senso proseguano, ampliando il lavoro svolto.
L’efficientamento energetico degli edifici
L’efficientamento energetico degli edifici rappresenta uno dei principali obiettivi del PNRR, in particolare attraverso le risorse per il finanziamento del Superbonus 110%.
Dai dati ancora parziali pubblicati dall’ENEA, è possibile stimare che gli obiettivi della misura, in termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2, siano stati ampiamente superati.
Tuttavia, un’analisi costi-benefici, fatta sia a livello aggregato sia a livello di singola tipologia di intervento incentivato, restituisce un tempo di ritorno dell’investimento del Superbonus abbastanza elevato (circa 35 anni), non coerente con l’orizzonte di vita utile degli interventi incentivati.
Tale conclusione trova sostanziale conferma anche considerando un costo per lo Stato al netto delle maggiori entrate fiscali generate dalla misura (circa 24 anni).
Dati che fanno guardare con favore alla scelta del Governo di rivedere, in netta riduzione, la portata agevolativa della misura in discorso.
Inoltre, la forte eterogeneità, quanto ad anni di ritorno, tra i singoli interventi oggetto di incentivazione nel quadro della misura sembrerebbe giustificare uno schema di detrazioni differenziate, che preveda aliquote tanto maggiori quanto più efficiente è l’intervento incentivato.
Nel confronto con gli obiettivi di policy, al 2024 il Superbonus ha generato una traiettoria di consumi energetici più che conforme all’evoluzione prevista dal PNIEC 2020 e dal PNIEC 2024.
Tuttavia, rivolgendo lo sguardo all’orizzonte del 2030, il contributo positivo del Superbonus allo scenario di riferimento del consumo energetico del settore residenziale non appare sufficiente ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati al 2030 dal nuovo PNIEC.
In maggior dettaglio, a politiche invariate, il Superbonus, che dal 2020 al 2024 ha generato una riduzione di consumi di circa 2 Mtep, è appena sufficiente per rispettare gli obiettivi del vecchio PNIEC, mentre mancherebbe un’ulteriore riduzione di 2 Mtep per rispettare gli obiettivi al 2030 del nuovo PNIEC.
Il PNRR, nel quadro della seconda Missione, terza Componente (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), prevede, oltre al potenziamento della rete di teleriscaldamento, tre tipologie di interventi su questo tema:
• 1) “Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica”;
• 2) “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”;
• 3) “Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia”.
Passando alla seconda classe di interventi, costituita da opere di efficientamento dell’edilizia pubblica tramite la demolizione e costruzione di più di 200 nuove scuole e la riqualificazione di più di 50 edifici giudiziari, è al momento difficile quantificare i risparmi energetici di tali interventi e compararli con l’obiettivo di 4 Ktep/anno, vista la mancanza dei dati energetici degli edifici interessati.
Ciononostante, un esercizio di stima preliminare, svolto sfruttando le informazioni presenti sui certificati energetici di due istituti scolastici lombardi interessati dagli interventi, restituisce risultati che sembrano confermare come l’obiettivo di risparmio energetico finale per la misura di edilizia scolastica possa essere raggiunto.
Sugli uffici giudiziari non è stato possibile presentare una stima, ma un’analisi della descrizione degli interventi indica che i risultati in termini di risparmio energetico di questa particolare misura saranno probabilmente marginali.
Le infrastrutture energetiche
A valere sulle 8 misure del PNRR volte a sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche (con risorse per 5,5 miliardi) risulta attivata la ripartizione per 53 progetti, che segnano un grado di avvicinamento ai target assegnati pari al 5,7 per cento: un valore ancora basso, a motivo del fatto che il cronoprogramma del Piano prevede la chiusura della fase di selezione dei progetti entro il 2024, per poi concentrarne la fase esecutiva nel biennio 2025-26.
Questa tipologia di finanziamenti è comunque riservata a operatori altamente specializzati e con elevata capacità di spesa e ciò dovrebbe rappresentare una garanzia per la tempestiva conclusione dei progetti.
Le misure del PNRR volte a sostenere l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche rappresentano una vera e propria tecnologia abilitante della transizione; in questo ambito il Piano accoglie in particolare investimenti volti a favorire l’adeguamento della rete di distribuzione elettrica.
Per contribuire agli obiettivi di sicurezza energetica, apposite misure sono poi dedicate alla rete di trasmissione del gas naturale.
In entrambi i casi le esigenze di investimento sono legate al maggior utilizzo di nuove fonti (le rinnovabili per la rete elettrica; il GNL e in prospettiva l’idrogeno per la rete gasifera) e alla maggiore rilevanza che assumeranno i flussi provenienti dalle regioni meridionali. Si tratta complessivamente di otto misure a cui sono indirizzati finanziamenti per 5,5 miliardi.
Al momento, i progetti per cui sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse (e di cui è possibile un monitoraggio all’interno della banca dati ReGiS) sono 53; la verifica sull’avvicinamento ai target assegnati indica un grado di conseguimento pari al 5,7 per cento.