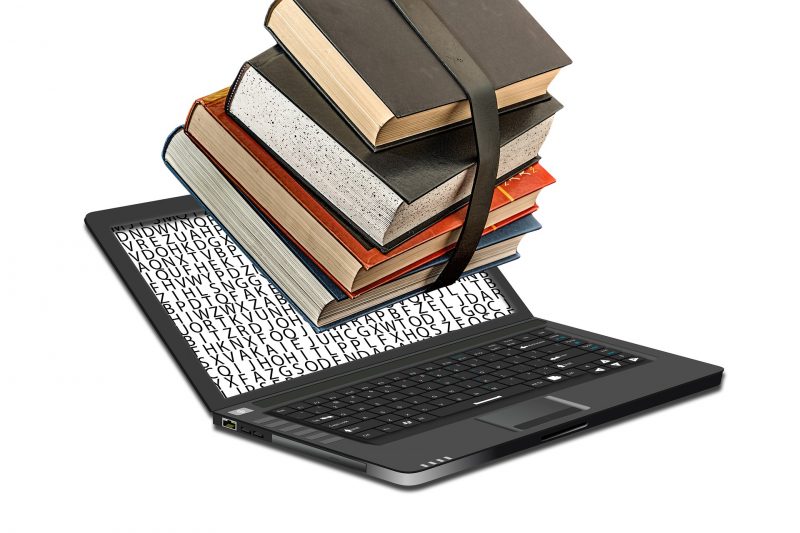ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
Mutui a tasso variabile: quello che non quadra e le opportunità
Con l’aumento del tasso base (Euribor) le rate dei mutui da costanti nel tempo, a parità di tasso, sono divenute a rate decrescenti caricando il maggior impatto nel breve periodo: esattamente il contrario delle esigenze dei mutuatari.
La surroga a tasso fisso è la miglior opportunità per i mutuatari a tasso variabile se lo spread contrattuale è superiore all’1%
Non c’è una ricetta unica per i mutuatari a tasso variabile per parare il colpo dell’aumento della rata. Per coloro che sono molto avanti nel piano di rimborso è probabile che la situazione sia sopportabile poiché il debito è ridotto di molto rispetto all’avvio ed i maggiori interessi generati dall’aumento dell’euribor non incidono più di tanto.
Cambia la musica per coloro che sono partiti una decina di anni fà. Con l’Euribor tendente allo zero le banche applicarono uno spread (che si aggiunge all’Euribor tasso base) più alto del solito, per avere un margine di interesse più consistente, compreso tra l’1,5% ed il 2%. Oggi che l’euribor sta tra il 3,6% annuo (Euribor 1 mese) ed il 3,9% annuo (Euribor 6 mesi) lo spread applicato sui nuovi mutui in emissione è di circa l’1%. I mutui emessi allora hanno oggi un tasso finito (Euribor + Spread) tra il 5 ed il 5,5%. I nuovi mutui a tasso pur sempre variabile sono emessi ad un tasso finito tra il 4,5% d il 4,9%.
La surroga, ovvero il cambio del creditore-banca a costo zero, consentita a tutti, a parità di tasso variabile taglierebbe il tasso passivo di 0,5%/1% annuo a crescere in funzione dello spread corrente. E non è poco!
Se però si volesse evitare l’ansia del tasso variabile e di eventuali rialzi futuri, allora l’alternativa è la surroga a tasso fisso. Alla corsa dell’Euribor (tasso variabile) non ha fatto riscontro, se non parzialmente, quella del tasso fisso (IRS), che oggi è più basso sulle scadenze lunghe, ovvero a 20 anni sta sul 2,9% annuo. Un nuovo mutuo a tasso fisso, o una surroga a tasso fisso, su quella durata avrebbe un tasso finito pari al 3,9% con un risparmio più consistente!
E’ bene sottolineare che storicamente il tasso fisso sta sopra il tasso variabile, se oggi non è così e perché il mercato sconta, giustamente o meno è una scommessa, un futuro ribasso dell’Euribor……
Le banche scaricano il rialzo dell’Euribor in modo istantaneo sulle rate di ammortamento trascurando il rischio cliente ed i doveri sanciti dal Testo Unico Bancario. La rinegoziazione delle condizioni è prevista.
Ad ogni aumento dell’euribor le banche ricalcolano la rata di ammortamento mantenendo fermo il piano di rimborso del capitale, in tal modo l’effetto negativo per il mutuatario è massimo. Se l’euribor non aumentasse più, paradossalmente, le rate diminuiranno nel tempo in corrispondenza della riduzione del debito residuo. In pratica da un piano di ammortamento a rata costante si passa ad uno a rata decrescente, contrario all’interesse del mutuatario.
Il mutuatario si trova in una condizione di rischio potenziale poiché scaricare l’aumento dell’euribor, mantenendo fermo il piano di rimborso del debito, potrebbe portarlo ad una condizione di non sostenibilità della rata rispetto al reddito. Tale rapporto (rata da sostenere rispetto al reddito) è anche la condizione di mutuabilità del richiedente in sede di istruttoria ed anche la variabile chiave che la banca dovrebbe considerare quando applica l’aumento dell’euribor.
L’art 120 del Testo Unico Bancario, comma septies, d’altronde, recita: “gli intermediari-finanziatori si comportano con diligenza….tenendo conto….degli interessi dei consumatori. Basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore….su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore”.
Il rischio cui è esposto il mutuatario è proprio il superamento della soglia di sopportabilità della rata e, dunque, l’art. 120, imporrebbe un intervento di rinegoziazione delle condizioni di mutuo.
La banca finanziatrice non fa consulenza ai propri clienti
La banca finanziatrice deve comportarsi con diligenza non solo in sede di concessione del mutuo, ma anche successivamente. Al rialzo dei tassi di interesse si è premurata di dialogare con i mutuatari riguardo l’aumentata probabilità (2021) di un rialzo del tasso Euribor? Se nel 2021 il mutuatario fosse passato ad un tasso fisso oggi dormirebbe tranquillo.
Prima del 2021 diversi anni di euribor discendenti verso lo zero o quasi hanno generato una situazione opposta a quella vigente, ovvero i mutuatari a tasso variabile hanno pagato meno del preventivato e, dunque, perché non sono stati invitati ad effettuare dei rimborsi parziali anticipati, anche di piccolo importo, con gli importi risparmiati? Riducendo il debito residuo anche l’aumento dell’euribor avrebbe avuto minor effetto.
A cura di Angelo Castagno
Direttiva Ue Case Green, sui pannelli solari l’accordo sembra lontano
- Ott 3, 2023
Procedono a rilento le trattative sulla nuova direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive) in materia di case green. L’obiettivo dichiarato è quello di dare attuazione alle nuove regole entro il 2030, ma i tempi per arrivare a un accordo su un testo condiviso da tutte le istituzioni europee sembrano dilatarsi. Inoltre si fa sempre più concreta la possibilità che il contenuto della normativa cambi rispetto alla versione iniziale.
A confermare queste ipotesi è, in particolare, l’esito del secondo incontro formale tra i rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione, che si è svolto a Bruxelles lo scorso giovedì 31 agosto.
Nel corso del secondo trilogo formale, infatti, i negoziati non hanno registrato quell’accelerazione decisiva che molti speravano, ma si sono ancora una volta arenati, per aggiornarsi a un nuovo incontro, il prossimo 6 ottobre.
Il motivo dello scontro tra Parlamento e Consiglio, rappresentato dalla presidenza di turno spagnola, è stato questa volta l’articolo 9, che tocca il tema dell’installazione di pannelli solari sugli edifici nuovi ed esistenti.
È stato soprattutto il terzo comma a provocare attriti. Nel testo in esame si dispone che i Paesi membri assicureranno l’installazione di pannelli solari secondo un calendario molto serrato. Già nel 2026 su tutti gli edifici pubblici e sugli edifici non residenziali, per poi coinvolgere gli altri edifici a scadenze progressive, tra il 2028 e il 2032.
Sul termine del 2026 non è stato trovato un compromesso, in quanto il Consiglio avrebbe preferito limitare l’installazione di pannelli solari solo agli edifici oggetto di ristrutturazione, anziché coinvolgere tutti gli immobili esistenti.
Qualche passo avanti, comunque, si è verificato. Il trilogo ha infatti ratificato l’accordo su una lunga lista di passaggi sui quali era stato trovato, nelle scorse settimane, un compromesso a livello tecnico: gli articoli 22, 23 e 24 – che riguardano gli esperti indipendenti che si occupano di verifiche legate all’efficienza energetica degli immobili, i professionisti dell’edilizia e i sistemi di controllo – sono pertanto stati archiviati.
Si tratta, comunque, di elementi che non sono centrali nella geografia del testo. Non è stato, invece, nemmeno avviato il confronto su alcuni dei passaggi chiave, come l’articolo 9, che fissa il contestatissimo calendario per le ristrutturazioni che i Paesi membri dovranno rispettare. È qui che si parla dell’obbligo di raggiungere la classe D entro il 2033, capitolo che, con la revisione del sistema degli attestati di prestazione energetica, rappresenta il cuore della direttiva.
Nelle prossime settimane si cercherà di accelerare, dal momento che incombe lo spettro della fine della legislatura europea e che, quindi, entro la fine dell’anno servono avanzamenti decisi per provare a completare il lavoro in tempo.
Nel mese di settembre si sono svolti quattro incontri tecnici (il 7, l’8, il 20 e il 21 settembre). Il 6 ottobre, invece, è in calendario il terzo trilogo formale.
La direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici è stata inserita nel pacchetto “Fit for 55”, presentato nel 2021 e pensato per allineare la normativa vigente in materia di clima ed energia al nuovo obiettivo di riduzione, entro il 2030, delle emissioni nette di gas a effetto di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, nella prospettiva della neutralità climatica entro il 2050.
Obiettivo della proposta di direttiva è quello di aumentare, tramite l’introduzione di norme minime di prestazione energetica, il tasso e la profondità delle ristrutturazioni degli edifici, nonché di migliorare le informazioni in materia di prestazione energetica e la sostenibilità degli edifici. Secondo la Commissione europea, infatti, gli edifici dell’Unione europea sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra.
Secondo quanto previsto al momento dalla direttiva europea sulle case green, gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033; gli edifici non residenziali e pubblici dovranno raggiungere le stesse classi energetiche rispettivamente entro il 2027 e il 2030; tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028, con la scadenza del 2026 per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche. La classe G dovrà corrispondere al 15% degli edifici con le prestazioni energetiche peggiori in ogni Stato membro.
Si ricorda che non tutti gli edifici dovranno essere sottoposti a interventi di ristrutturazione per migliorare la prestazione energetica. Le eccezioni riguardano:
• abitazioni unifamiliari di superficie inferiore a 50 metri quadri;
• seconde case utilizzate meno di quattro mesi l’anno;
• edifici a uso temporaneo;
• edifici con particolare valore storico e architettonico;
• chiese e gli altri edifici di culto;
• monumenti;
• edifici di proprietà delle Forze armate o del Governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale.
Se l’inquilino non paga il canone di locazione si può evitare il pagamento delle imposte
- Set 28, 2023
Il canone di locazione rappresenta una delle poche tipologie di reddito per le quali si applica il principio di competenza e non il principio di cassa. Questo implica che gli introiti derivanti dal canone di locazione devono essere generalmente indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui gli stessi maturano e non in quella in cui sono effettivamente riscossi.
Questa particolare norma può generare dei problemi dovuti a imposte da versare su redditi non riscossi e che non sempre si riescono a incassare.
Vediamo quindi cosa può fare il locatore nel caso in cui si trovi di fronte un inquilino che non paga il canone per non dichiarare le somme nel 730/2023 e quindi per evitare di pagare imposte su canoni non percepiti.
L’articolo 25 del Tuir ( decreto 917 del 1986) definisce redditi fondiari quelli derivanti da terreni e fabbricati. Ne consegue che i canoni di locazione devono essere annoverati in tale categoria.
L’articolo 26 del Tuir prevedeva che i redditi fondiari concorressero, indipendentemente dalla percezione (principio di cassa), a formare il reddito complessivo dei soggetti titolari di immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Allo stesso tempo stabiliva che i redditi derivanti da canoni di locazione non dovevano essere dichiarati nel caso in cui nel frattempo fosse stato concluso un procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto. In Italia questa procedura richiede molto tempo, di conseguenza il locatore si ritrovava a dover pagare anche per anni imposte su canoni di locazione effettivamente mai riscossi. In merito a questi importi era stabilito che tali versamenti fossero da considerare come credito di imposta e se effettivamente non riscossi potevano essere utilizzati in compensazione al termine del procedimento di convalida di sfratto.
Questa disciplina è sembrata al legislatore eccessivamente penalizzante per il locatore, soprattutto nel periodo di emergenza Covid, quando gli inquilini morosi sono aumentati e i locatori si sono trovati ad affrontare difficoltà economiche non di poco conto.
Proprio per evitare distorsioni, si è provveduto con il decreto legge 34/2019, decreto Crescita, art. 3 quinquies, a modificare tali norme.
Ora, in tema di canone da locazione, continua a trovare applicazione il principio di competenza e non il principio di cassa. La modifica importante riguarda però i tempi. Infatti per far valere nel modello 730 del 2023 la morosità dell’inquilino, non occorre più attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, ma basta dimostrare la mancata percezione degli introiti con l’ingiunzione di pagamento o ingiunzione di sfratto per morosità.
Questa norma trova applicazione per le mensilità non percepite a partire dal primo gennaio 2020, data di entrata in vigore della norma in oggetto.
Il nuovo testo dell’articolo 26 del Tuir recita: “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Sebbene non debbano essere dichiarati gli importi dei canoni di locazione maturati dopo l’ingiunzione di pagamento o ingiunzione di sfratto per morosità, nella dichiarazione 730/2023 deve comunque essere dichiarata la rendita catastale dell’immobile.
Per evitare di pagare le imposte sui canoni di locazione non percepiti, è necessario indicare nel modello 730/2023 nei righi B1-B6, colonna 7 (casi particolari) il codice 4. Se nello stesso anno una parte dei canoni sono stati percepiti, nella colonna 6 devono essere indicate le somme percepite, mentre nella colonna 7 il codice 4.
Bonus verde, la detrazione è attiva fino al 31 dicembre 2024
- Set 14, 2023
Vita condominiale: un italiano su tre discute o litiga con il vicino di casa
- Set 8, 2023
Più di 7 italiani su 10 vivono in contesti abitativi che richiedono di relazionarsi con vicini di casa e con un’organizzazione condominiale. Su questo tema Changes Unipol ha realizzato una nuova ricerca elaborata da Ipsos, finalizzata ad analizzare qualità e quantità dei rapporti interpersonali tra condòmini, grado di soddisfazione per l’operato dell’amministratore di condominio e, più in generale, rapporto con gli aspetti gestionali quali assemblee e spese condominiali.
Un italiano su tre litiga con il vicino: le motivazioni
Le relazioni degli italiani con i vicini sono abbastanza frequenti solo per il 37% degli italiani: il 27% dichiara di entrare in rapporto con il vicinato circa una volta a settimana, ma soltanto il 10% indica di farlo più volte al giorno. Due italiani su 10 sostengono di non avere del tutto interazioni.
Bologna è l’area metropolitana più attiva nelle relazioni di vicinato (il 61% indica almeno una volta a settimana), mentre Roma e Torino emergono per la maggior quota di assenza di interazioni (rispettivamente il 24% e il 21%). Tra le generazioni, i giovani della Generazione Z (16-26 anni) hanno le frequentazioni più assidue, nel 48% dei casi almeno una volta a settimana, seguite dai Baby Boomers (57-74 anni), mentre i Millennials (27-40 anni) e Generazione X (41-56 anni) sono più “schivi”, probabilmente anche per la minor presenza in casa negli orari lavorativi.
Le relazioni di vicinato sono definite dagli italiani prevalentemente “normali”: non c’è confidenza, ma ci si aiuta in caso di necessità (nel 59% dei casi). Tuttavia, non tutto procede sempre per il meglio, anzi: un italiano su tre ha avuto almeno una lite o un’accesa discussione con i vicini e, nel 15% dei casi, i litigi sono avvenuti anche più volte.
È Napoli la città che emerge come la più litigiosa tra le aree metropolitane (il 37% ha litigato almeno una volta), seguita in questa speciale classifica da Roma (34%), Cagliari (33%) e Torino (31%). Le città in cui le relazioni risultano più armoniose sono, invece, Firenze, dove il 79% dichiara di non aver mai avuto liti condominiali, Milano (75%) e Verona (75%).
Tra le fasce di età, sono i giovani Gen Z – che hanno anche le interazioni più frequenti con i vicini – a confermare di avere avuto più frequentemente liti o discussioni (nel 39% dei casi), mentre i Baby Boomers sono i più “pacifici”, visto che nel 77% dei casi non hanno mai avuto discussioni accese.
I motivi dei contrasti
In primis, nel 29% dei casi, si litiga per i rumori molesti o che avvengono in orari inadeguati, seguiti dai comportamenti “sgraditi” dei vicini (27% dei casi) e dal “parcheggio selvaggio” dei mezzi di trasporto (20%). Ma, se si analizzano le singole città, nell’Italia dei campanili ciascuna di esse presenta delle peculiarità.
In particolare, il parcheggio selvaggio dei mezzi di trasporto è un motivo di lite soprattutto a Napoli (3 persone su 10), mentre a Bari è il mancato o ritardato pagamento delle spese condominiali al centro delle discussioni (23%).
La gestione degli animali domestici genera discussioni soprattutto a Roma (21%), mentre a Milano è la gestione delle biciclette a creare dissapori (14%), assieme al servizio di portineria (10% dei casi). A Torino, invece, le liti nascono spesso per la gestione della raccolta differenziata (18%) e l’ostruzione del passaggio nell’atrio/pianerottolo con passeggini, monopattini o altri oggetti (14%).
A Verona e Firenze, infine, si discute più della media anche per gli interventi e spese del condominio (rispettivamente nel 24% e nel 22% dei casi), ma anche per la manutenzione del giardino (rispettivamente 13% e 14% dei casi).
Tra le generazioni, un quarto della Gen X (il 25%) litiga per il parcheggio improprio dei mezzi di trasporto, mentre per la Gen Z il primo motivo di discussione in assoluto sono i comportamenti sgraditi degli altri condòmini, nel 26% dei casi. Quasi un Baby Boomer su quattro (il 23%) segnala, invece, i ritardi nel pagamento delle spese condominiali.
Metà degli italiani sono scontenti dell’amministratore di condominio
Un italiano su due, per l’esattezza il 52% degli italiani, non è soddisfatto del proprio amministratore di condominio. In particolare, sono le grandi metropoli a registrare la più alta delusione: i romani, con un 64% di giudizi negativi, risultano essere i più scontenti, seguiti dagli abitanti di Milano (56%). Bologna e Cagliari sono invece le città con le valutazioni più positive con, rispettivamente, il 43% e il 38% che promuove l’operato dell’amministratore con un voto pari almeno ad 8, a fronte di una media nazionale del 26%.
Tra le generazioni, i più soddisfatti dell’amministratore, nel 32% dei casi, sono i Baby Boomers, mentre Gen X e Millennials sono i più critici, con giudizi negativi rispettivamente nel 56% e nel 55% dei casi.
I principali motivi di insoddisfazione sono legati alla scarsa capacità propositiva dell’amministratore per la risoluzione dei problemi ed esigenze condominiali (nel 36% dei casi), alla non soddisfacente gestione amministrativa (34%), ma anche alla percezione di una certa distanza da interessi ed esigenze dei condomini (34%). Più in generale, chi si lamenta dell’amministratore è portato a farlo comunque più per motivi legati alla sua scarsa capacità nell’esercizio della funzione (nell’82% dei casi) che per motivi legati a scorrettezza o disonestà (67% dei casi).
L’insoddisfazione per la gestione amministrativa è maggiore a Roma (48%), Bologna (46%) e Napoli (44%) e, quella per la scarsa reperibilità dell’amministratore a Milano (45%) e Firenze (42%), mentre Torino e Firenze lamentano la scarsa trasparenza (rispettivamente 38% e 31%). Cagliari e Napoli, invece, segnalano le scarse capacità organizzative dell’amministratore (36% e 33%), mentre la gestione economica risulta poco soddisfacente a Bologna (35%) e Torino (31%).
Tra le diverse generazioni, la metà dei Baby Boomers lamenta la scarsa propositività dell’amministratore (nel 51% dei casi) e il suo scarso orientamento verso le esigenze dei condomini (46%), posizione quest’ultima condivisa con la Gen Z (48% dei casi), mentre i Millennials e la Gen X criticano soprattutto la gestione amministrativa, rispettivamente nel 38% e nel 37% dei casi.
Assemblea di condominio: un italiano su due partecipa assiduamente
Il tema della gestione del condominio è importante per gli italiani, che infatti intervengono numerosi alle assemblee condominiali (il 72% partecipa, di cui il 49% sempre o quasi sempre). Le città più attive sono Bari e Bologna, dove almeno sei condòmini su 10 prendono parte alle riunioni condominiali quasi sempre. Le città più assenteiste, invece, sono Milano e Verona, dove un terzo non partecipa quasi mai.
I Baby Boomers sono i più assidui partecipanti (78%), mentre i più assenteisti sono Gen Z e Millennials, che in un terzo dei casi non si presentano mai o quasi mai.
Le riunioni di condominio attualmente si svolgono principalmente in presenza (nel 77% dei casi), che risulta anche la modalità preferita per il 64% degli intervistati, anche se il 18% degli italiani le preferirebbe a distanza, on-line, (modalità ad oggi praticata solo nel 5% dei casi). In particolare, sono soprattutto i milanesi (35% dei casi), ma anche i romani (26%) a preferire maggiormente le riunioni on-line. Tra le generazioni, Millennials e Gen X, più outdoor e impegnati al lavoro durante la giornata, evidenziano il maggiore interesse per la modalità a distanza.
Complessivamente solo due italiani su 10 si dicono pienamente soddisfatti delle riunioni di condominio (voti da 8 a 10) e la città con la più alta quota di soddisfatti è Bologna, seguita da Cagliari, mentre Roma e Napoli sono le aree metropolitane in cui l’insoddisfazione è più diffusa (voti da 1 a 5).
Il motivo di insoddisfazione principale è l’assenteismo da parte dei condòmini (37%), seguito dalla scarsa frequenza delle assemblee (34%), dall’impossibilità di dialogare civilmente (27%) e dalla mancata mediazione da parte dell’amministratore in caso di discussioni (25%)
Per Millennials e Gen X l’insoddisfazione è legata principalmente all’orario inadeguato e quindi all’esigenza di maggiore flessibilità, dovuta alla loro maggiore necessità di conciliare lavoro e gestione della casa e della famiglia (rispettivamente 28% e 25% a fronte della media nazionale del 22%).
Gli italiani affermano, infine, di pagare mediamente spese condominiali per circa 100 euro mensili, un ammontare ritenuto però inadeguato da un intervistato su tre (32%). Milano e Bologna dichiarano spese mensili sopra media, rispettivamente di 162 euro e 132 euro.
Tutte le città vorrebbero – naturalmente – pagare spese condominiali inferiori alle attuali, in primis Milano, i cui abitanti vorrebbero ridurle di quasi il 40%, così da allinearsi alla media nazionale.
Comunicato Stampa
Fotovoltaico e solare negli edifici in condominio
- Set 7, 2023
Il fotovoltaico e il solare termico in condominio, così come in un’abitazione singola, comportano diversi vantaggi per gli utenti. Si tratta, infatti, di tecnologie che assicurano notevoli risparmi economici e benefici ambientali e che, nel corso degli anni, si sono ampiamente diffuse anche in ambito residenziale.
Pannelli fotovoltaici e solari termici, del resto, hanno oggi costi più accessibili, rientrano tra le opere di efficientamento energetico che consentono di accedere a una serie di agevolazioni fiscali e favoriscono il taglio dei costi in bolletta per l’acquisto di energia.
Il fotovoltaico, in particolare, permette l’autoproduzione di energia, che riduce in modo significativo la dipendenza dalla rete elettrica nazionale.
Naturalmente, il livello di indipendenza varia a seconda della tipologia di edificio, del profilo di consumo dell’utente e dalla predisposizione di tecnologie, quali i sistemi di accumulo.
Nel caso specifico del condominio, però, ci sono alcune importanti informazioni da conoscere.
Fotovoltaico e solare termico in condominio: impianto centralizzato e privato
Quando si decide di installare un impianto fotovoltaico o solare termico in condominio la prima questione da affrontare riguarda la proprietà dello stesso.
Il discorso vale principalmente per il fotovoltaico, dato che un impianto può essere centralizzato e, quindi, di proprietà del condominio, oppure privato, ossia di un solo condòmino.
A seconda delle circostanze, cambia la modalità con cui si utilizza l’energia prodotta dai pannelli. Nel caso si tratti di un impianto privato, l’energia viene consumata dal condòmino che ha sostenuto l’investimento, all’interno del proprio appartamento. Nel caso sia invece un impianto centralizzato, l’energia prodotta non viene ripartita tra i vari condòmini per usi domestici, bensì è utilizzata per ammortizzare la spesa sostenuta per gli spazi comuni, come l’illuminazione o il funzionamento dell’ascensore.
La comunità energetica di condominio
Esiste, poi, una terza strada: la comunità energetica condominiale.
In questo caso, viene costituita una comunità energetica i cui membri sono i diversi condòmini. Una comunità energetica è un insieme di utenti singoli che, tramite un apposito documento di costituzione e uno specifico regolamento, producono e scambiano energia pulita.
Può essere costituita tra soggetti dislocati sul territorio, ma se il confine è il condominio, si parla di comunità energetica condominiale.
In questo caso, l’impianto produce energia e tutti i condòmini che aderiscono possono beneficiarne. Da qui deriva la definizione di autoconsumo collettivo, dato che l’energia viene virtualmente distribuita sulla base del fabbisogno rilevato in quel momento.
Per costituire una comunità energetica non è necessario che tutti i condomini partecipino, ma ne sono sufficienti due.
Naturalmente, prima di procedere nella costituzione di una comunità energetica condominiale, è bene procedere con uno studio di fattibilità, finalizzato a verificare le superfici disponibili e la conformazione dell’immobile, ma anche a mappare i consumi degli utenti e calcolare i benefici che si otterrebbero.
Le autorizzazioni necessarie per fotovoltaico e solare in condominio
Per quanto riguarda il tema delle autorizzazioni necessarie, si deve precisare che nel caso si tratti di un impianto fotovoltaico di proprietà del condominio è necessaria un’assemblea e una votazione favorevole da parte di almeno la metà dei condomini. L’iter è stato semplificato con la Riforma del Condominio, che ha agevolato innovazioni quali l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Nel caso vi siano condòmini contrari, non si potrà chiedere loro di sostenere le spese per l’acquisto e l’installazione del fotovoltaico. Allo stesso tempo, però, non potranno godere dei benefici derivanti dallo stesso.
Se, invece, si tratta di impianti privati, siano essi fotovoltaici o solari termici, è possibile per il singolo condòmino procedere all’installazione sia su parti comuni, sia sulle proprietà che gli appartengono. In questo secondo caso, non serve una preventiva comunicazione all’assemblea. Mentre in caso di superfici comuni, come quella della copertura, è necessario comunicare all’amministratore quanto si vuole realizzare, in modo che questi possa convocare un’assemblea condominiale e informare tutti i condòmini ed eventualmente verificare la fattibilità e la conformità dell’intervento.
L’esito del confronto in assemblea può riguardare indicazioni in merito al progetto e all’installazione, ma non è possibile negare l’uso di spazi comuni per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché non siano compromessi stabilità e decoro architettonico dell’edificio.
Impianti fotovoltaici: le alternative al tetto o agli spazi comuni
In alternativa agli spazi comuni, come lastrici solari e coperture, i singoli condòmini sono liberi di installare un impianto privato sulle rispettive proprietà. è comunque bene ricordare che ci sono anche alcune alternative alle classiche ubicazioni.
Ad esempio, sempre più spesso si sente parlare del fotovoltaico “da balcone”, che può essere installato senza alcuna autorizzazione. L’intervento rientra infatti tra le opere di edilizia libera e sul mercato si trovano piccoli impianti installabili anche in totale autonomia. Chiaramente si tratta di impianti che consentono piccole produzioni, inferiori a 1 kWh. Hanno costi accessibili e occupano poco spazio, tanto da essere installati anche sulle sole ringhiere. Per quanto non sia necessaria una delibera d’assemblea, però, è sempre meglio dare comunicazione all’amministratore di quanto si vorrebbe realizzare e installare.
Amministratori di condominio, in Parlamento si torna a discutere dell’istituzione del Registro nazionale
- Set 6, 2023
Il testo del Disegno di legge presentato al Senato lo scorso ottobre. La proposta è stata presentata dal Senatore Giorgio Maria Bergesio, che anche nella scorsa legislatura aveva sollevato il tema
Il presente disegno di legge è finalizzato all’istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio allo scopo di introdurre garanzie a tutela sia dei singoli condomini sia della professionalità degli operatori del settore, che non sono adeguatamente tutelati dalla vigente normativa.
I requisiti per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio sono disposti dall’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n.220.
Tuttavia l’attuale previsione legislativa non garantisce la professionalità dell’amministratore, qualora sia interno allo stabile e quindi condòmino, in quanto non contempla il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado né lo svolgimento di un corso di formazione iniziale, oltre a quello di aggiornamento periodico regolamentato dal Decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2014, n. 140.
È doveroso segnalare che nel nostro ordinamento l’attività professionale di amministratore di condominio non è ancora regolamentata, seppure tale figura rivesta un’importanza fondamentale, in quanto gli amministratori di condominio sono i gestori del patrimonio immobiliare italiano.
Il legislatore ha inteso regolamentare molteplici professioni quali, ad esempio, l’acconciatore, l’assistente sociale, l’autoriparatore, il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, ma non l’amministratore di condominio.
L’esigenza di istituire un Registro scaturisce dalla mancanza, all’interno del nostro ordinamento, di un sistema selettivo che valuti i requisiti di accesso alla professione.
Il citato articolo 71-bis, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie stabilisce che: “Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che:
• a) hanno il godimento dei diritti civili;
• b) non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
• c) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• d) non sono interdetti o inabilitati;
• e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
• f) hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• g) hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
Ma non vi è alcun ente che verifica la sussistenza dei suddetti requisiti.
In relazione a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma del citato articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, è opportuno segnalare che in Italia sono operative ben oltre cinquanta associazioni di categoria che organizzano corsi di avviamento e aggiornamento per la professione di amministratore di condominio. Ma solo un terzo di queste risulta iscritta nell’apposito elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previsto per quelle associazioni che rilasciano un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
È evidente che la semplice frequenza di un corso all’avviamento della professione, o di aggiornamento annuale, seppur tenuto da un’associazione di categoria, non costituisce un elemento utile a fornire alcuna garanzia in merito alla professionalità degli amministratori di condominio.
Si può affermare, senza ombra di dubbio, che un qualsiasi soggetto potrebbe esercitare la professione di amministratore di condominio, e quindi gestire denaro altrui, senza alcun controllo in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Questa situazione si ripercuote negativamente sia sui condòmini, in quanto sovente si crea un disorientamento in merito alla scelta del professionista cui affidare l’amministrazione dello stabile, sia su tutti quegli amministratori di condominio che, pur operando con competenza e correttezza, sono confusi con i colleghi meno professionali e trasparenti, che compiono illeciti e, con il loro operato, ingenerano le numerose controversie che, purtroppo, si registrano nel settore.
È il caso di riferire che oggi, presso i tribunali italiani, pendono circa due milioni di giudizi civili che hanno ad oggetto contenziosi di natura condominiale.
Tale situazione può essere superata con un processo di valorizzazione della figura dell’amministratore di condominio, anche in considerazione del mutato contesto nel quale si trova oggi ad operare. Un contesto nel quale, alle peculiarità proprie del patrimonio e della proprietà immobiliare del nostro Paese, si sono aggiunte nuove e articolate esigenze.
Tra emergenze abitative, frammentazione della proprietà immobiliare e vetustà dei fabbricati, a cui hanno fatto seguito misure di riqualificazione energetica e antisismica che comportano l’acquisizione di ulteriori e complesse competenze, l’amministratore di condominio è chiamato a ricoprire una pluralità di ruoli che, a loro volta, richiamano molteplici adempimenti e responsabilità. Da ciò scaturisce la necessità di individuare strumenti adeguati per stimolare una crescita professionale e, nel contempo, per responsabilizzare maggiormente gli operatori rispetto al contesto nel quale operano, soprattutto a tutela dei condòmini.
I dati del settore giustificano questa esigenza. Secondo la settima edizione del rapporto “Gli immobili in Italia” del 2019, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Società generale d’informatica Spa (Sogei), il patrimonio immobiliare è composto da oltre 63 milioni di unità immobiliari, di cui oltre 34 milioni (il 54 per cento) sono abitazioni. Si stima, inoltre, che i condòmini siano oltre 1.200.000, mentre, secondo una ricerca della Confederazione europea delle professioni immobiliari (CEPI), il numero degli amministratori di condominio è pari a circa 300.000.
Questa professione assume particolare rilievo in relazione a due peculiarità del contesto italiano: la vetustà degli edifici e la distribuzione della proprietà immobiliare.
Due elementi che pongono con forza al centro della gestione del fabbricato l’amministratore condominiale, diviso tra il ruolo di mediatore tra le diverse volontà e i diversi interessi degli inquilini e dei proprietari, di gestore della manutenzione del bene immobile, di consulente e interprete delle misure che incentivano la riqualificazione dell’abitazione, con la gestione anche di consistenti flussi di denaro.
A questo proposito è il caso di segnalare che, per quanto attiene alla vetustà del patrimonio abitativo, dai dati del 15° Censimento dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) della popolazione e delle abitazioni del 2011 emerge che:
• il 53,7 per cento delle abitazioni ha più di quarant’anni ed è quindi stato costruito prima dell’entrata in vigore dellaLegge 30 aprile 1976, n. 373, per il contenimento del consumo energetico per usi termici degli edifici;
• il 31 per cento del patrimonio abitativo è stato edificato nel ventennio successivo;
• il 7,4 per cento del patrimonio abitativo è stato edificato nel periodo 1991-2000;
• soltanto il restante 7,69 per cento del patrimonio abitativo è stato edificato dopo il 2001.
Per quanto riguarda, invece, la distribuzione della proprietà immobiliare, il citato rapporto “Gli immobili in Italia” sostiene che il 75,2 per cento delle famiglie, tre su quattro, risiede in una casa di proprietà. La frammentarietà della proprietà accentua il ruolo di mediatore dell’amministratore di condominio in un contesto nel quale il patrimonio immobiliare rappresenta un valore complessivo di oltre 6.000 miliardi dieuro.
Il presente disegno di legge prevede, ai fini di un controllo della regolare iscrizione dell’amministratore al Registro nazionale degli amministratori di condominio, che l’accesso alle agevolazioni fiscali connesse agli interventi sugli immobili sia subordinato all’iscrizione al Registro da parte dell’amministratore dell’immobile, e che, ai fini dell’apertura del conto corrente del condominio, le banche incaricate verifichino preventivamente l’iscrizione dell’amministratore del condominio al Registro.
Il disegno di legge è così articolato:
• l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità della legge;
• l’articolo 2 stabilisce che il Registro è istituito presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
• l’articolo 3 indica le modifiche da apportare all’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;
• l’articolo 4 definisce i requisiti per richiedere l’iscrizione al Registro da parte di coloro che già svolgono l’attività;
• l’articolo 5 disciplina la materia dei corsi di qualificazione e di aggiornamento;
• all’articolo 6 è prevista l’individuazione delle norme deontologiche alle quali improntare i comportamenti degli iscritti al Registro;
• l’articolo 7 disciplina le modalità di iscrizione al Registro;
• l’articolo 8 prevede le attività subordinate all’iscrizione al Registro medesimo.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1 – Oggetto e finalità
– 1 – La presente legge disciplina l’istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio, come riconosciuti ai sensi degli articoli 1129 e seguenti del Codice civile.
– 2 – La presente legge disciplina altresì le modalità di formazione e di tenuta del Registro, i requisiti per l’iscrizione e le cause di cancellazione dal medesimo Registro.
– 3 – La presente legge è finalizzata a:
• a) conseguire la rigorosa applicazione di quanto disposto dall’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, per lo svogimento dell’attività di amministratore di condominio;
• b) tutelare i diritti e gli interessi dei proprietari di immobili e dei loro inquilini;
• c) garantire e attestare la professionalità dei soggetti esercenti l’attività di amministratore di condominio;
• d) promuovere una generale valorizzazione della figura dell’amministratore dicondominio, tenuto conto delle implicazioni sociali della professione e della crescente complessità delle funzioni che è chiamato a svolgere.
Art. 2 – Registro nazionale degli
amministratori di condominio
– 1 – Presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia è istituito il Registro nazionale degli amministratori di condominio, di seguito denominato “Registro”, a cui sono tenuti obbligatoriamente a iscriversi tutti i soggetti che, informa singola o associata, svolgono o intendono svolgere tale attività professionale.
– 2 – La formazione del Registro e la sua revisione, nonché l’istituzione di eventuali sezioni separate, la cui formazione dovesse ritenersi necessaria, sono disciplinate con appositi decreti del Ministro della Giustizia. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia.
– 3 – All’istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero della Giustizia disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 3 – Modifiche all’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
– 1 – All’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n.318, sono apportate le seguenti modificazioni:
• a) al primo comma, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: -g-bis) che sono iscritti al Registro nazionale degli amministratori di condominio;
• b) il secondo comma è abrogato.
Art. 4. – Requisiti per l’iscrizione al Registro
– 1 – In sede di prima applicazione della presente legge, possono chiedere l’iscrizione al Registro, secondo quanto disposto all’articolo 7, commi 1 e 2, della presente legge, purché in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71-bis, primo comma, lettere da a) a f), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo1942, n. 318:
• a) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
• b) i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea residenti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocità, salvo il caso degli apolidi;
• c) i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalle associazioni di categoria o equipollenti e dei successivi attestati di aggiornamento periodico, previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2014, n.140.
– 2 – Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, possono altresì presentare domanda di iscrizione al Registro, secondo quanto disposto all’articolo 7,commi 1 e 2, della presente legge, i soggetti in possesso di partita IVA che abbiano esercitato continuativamente, per almeno due anni, la professione di amministratore di condominio, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 71-bis,primo comma, lettere da a) a f), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
– 3 – La mancata iscrizione al Registro preclude l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio.
Art. 5. – Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale
– 1 – In considerazione di quanto stabilito dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, le associazioni di categoria iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy o gli altri soggetti deputati alla formazione iniziale e periodica degli amministratori di condominio sono tenuti a promuovere e organizzare:
• a) corsi di formazione professionale per il conseguimento della relativa qualifica;
• b) corsi di aggiornamento annuali per i soggetti già iscritti al Registro, con riconoscimento dei relativi crediti formativi.
Art. 6. Regolamento
– 1 – Il Ministro della Giustizia, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
• a) le norme comportamentali e profesionali al cui rispetto è subordinata la permanenza dell’iscrizione al Registro, definite all’interno di un codice deontologico;
• b) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4 della presente legge e dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71-bis, primo comma, lettere da a) a f), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318;
• c) l’importo annuale da versare quale quota di iscrizione al Registro.
Art. 7. Domanda di iscrizione al Registro
– 1 – L’iscrizione al Registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato, contenente i dati anagrafici e fiscali, l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), la località di prevalente svolgimento dell’attività professionale, nonché l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 71-bis, primo comma, lettere da a) a g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318.
– 2 – L’iscrizione è disposta con provvedimento del dirigente responsabile del competente ufficio, previo accertamento dei requisiti di cui al citato articolo 71-bis, primo comma, lettere da a) a g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, nonché previa verifica del versamento della quota di iscrizione annuale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge.
– 3 – Con la medesima procedura di cui al comma 2 sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e l’accettazione della domanda di cancellazione.
– 4 – I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall’espressione del parere da parte dell’ufficio competente e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi del comma 1, e devono essere motivati e comunicati all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento o PEC.
– 5 – L’ufficio di cui al comma 2 provvede alla tenuta del Registro, alla revisione e all’aggiornamento periodici in relazione al permanere dei requisiti professionali richiesti dalla legge, nonché alla cancellazione dal Registro dei nominativi dei soggetti che ne avanzino richiesta o che perdano i requisiti soggettivi o che violino le norme comportamentali e professionali di cui al regolamento previsto dall’articolo.
– 6 – All’interno del Registro sono riportate le informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui al comma 1.
Art. 8. – Attività subordinate all’iscrizione al Registro
– 1 – L’accesso alle agevolazioni fiscali previste per gli interventi sugli immobili è subordinato all’iscrizione al Registro dell’amministratore di condominio dell’immobile.
– 2 – Ai fini dell’apertura del conto corrente del condominio, le banche incaricate verificano l’iscrizione al Registro dell’amministratore del condominio.
Ascensore: tutti i condomini devono pagare le spese
- Ago 11, 2023
Impianti fotovoltaici in strutture turistiche e termali
- Ago 7, 2023
Con il voto di fiducia al Senato, lo scorso 24 maggio è stato convertito il decreto legge n. 34/2023, meglio conosciuto come “Decreto Bollette”, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.
Tra le varie modifiche e novità, la legge introduce l’art. 7-bis attraverso il quale viene semplificata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali.
Difatti, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, fino al 30 giugno 2024 nelle strutture turistiche e termali sarà possibile collocare gli impianti fotovoltaici su coperture piane o falde, di potenza fino a 1MW e destinati all’autoconsumo, presentando semplicemente la DILA (Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata).
Per quanto riguarda le strutture turistiche e termali site nei centri storici o in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è possibile utilizzare la procedura semplificata per il fotovoltaico sul tetto a patto che ricorrano le seguenti condizioni:
• gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti panoramici;
• i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti e materiali della tradizione locale.
La DILA andrà presentata al Comune o in via telematica o in formato cartaceo, insieme ad una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti il rispetto delle norme igienico-sanitarie, antisismiche e di sicurezza. Per quanto concerne gli impianti da realizzarsi nei centri storici o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è necessario anche presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti fotovoltaici non siano visibili da spazi pubblici esterni limitrofi e dai punti panoramici.
La citata normativa e la relativa semplificazione in materia di installazione del fotovoltaico nelle strutture turistiche e termali, si pone in continuità con quanto disposto lo scorso anno dal “Decreto Aiuti”, convertito con legge n. 91/2022, il quale ha consentito l’utilizzo della DILA per gli impianti destinati all’autoconsumo e siti al di fuori dei centri storici e delle aree tutelate.
In seguito il “Decreto Aiuti bis” (legge n. 142/2022) ha definito la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle strutture turistiche e termali site nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico a condizione che vi sia un’attestazione del progettista che dichiari che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
Inoltre, la semplificazione introdotta dal “Decreto Bollette” in merito all’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali arriva anche dopo il cosiddetto “Decreto Energia” (legge n. 34/2022) attraverso il quale sono stati classificati come interventi di manutenzione ordinaria (quindi non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso) l’installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici, strutture e manufatti fuori terra, compresa la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica e l’installazione di pannelli integrati nelle coperture in regime di edilizia libera, purché questi non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti panoramici nei centri storici e nelle aree tutelate.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Attivare e gestire il sito internet del condominio
- Ago 4, 2023