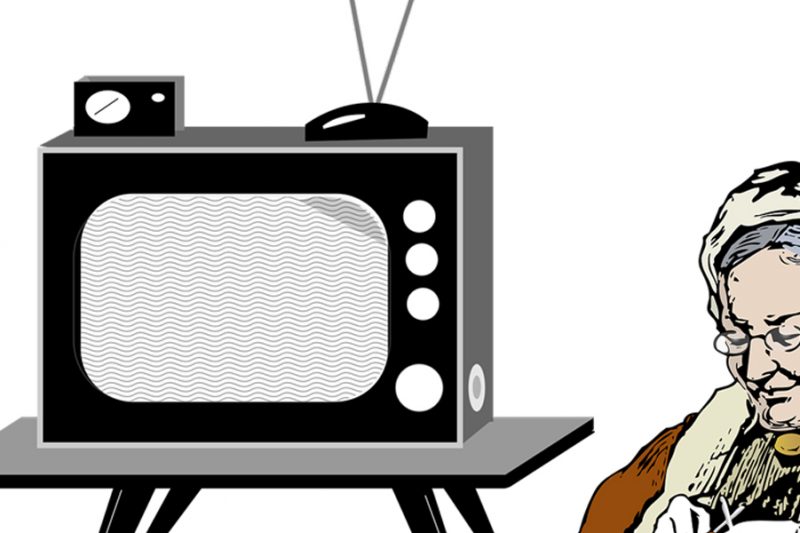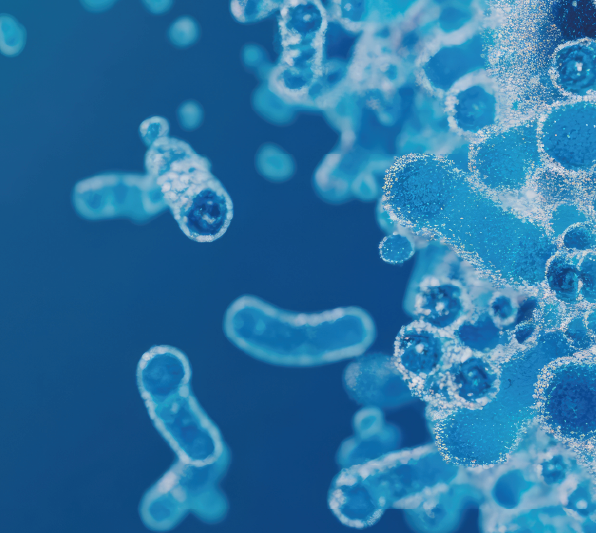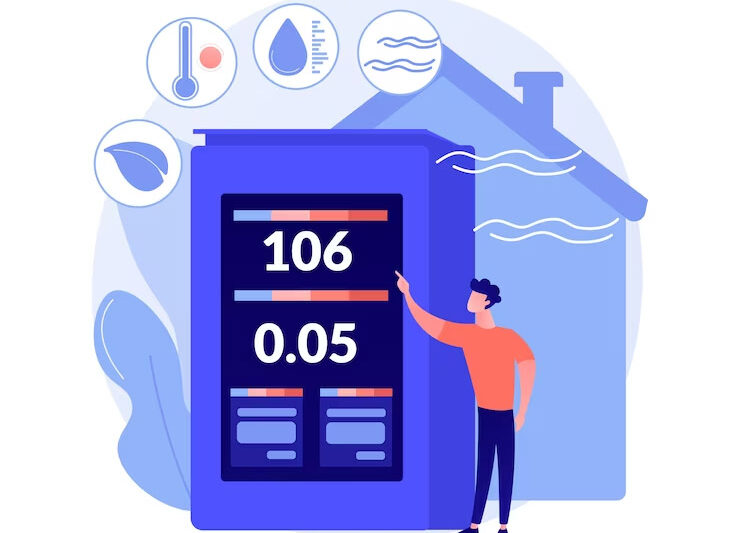Varie
Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale Daikin
Il 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l’evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria, che vanta il più ampio portafoglio di prodotti per applicazioni residenziali e commerciali. Questa nuova edizione del Daikin Tour conferma l’impegno dell’azienda nel presentare le ultime novità di prodotto e nel supportare i professionisti del settore HVAC attraverso formazione, aggiornamento tecnico e confronto diretto.
Il Tour sarà articolato in 41 tappe distribuite su tutta Italia, con partenza da Prato e arrivo a Pescara il 28 maggio. Un percorso di circa cinque mesi che attraverserà le principali città italiane, prevedendo in ogni tappa un evento formativo rivolto ai progettisti – ingegneri, architetti, geometri e periti industriali – valido come aggiornamento professionale con il riconoscimento di crediti formativi, affiancato da un momento di incontro e approfondimento dedicato agli installatori.
Il tema centrale dell’edizione 2026 sarà l’analisi delle principali misure di incentivazione per l’efficienza energetica, con un focus specifico su Conto Termico 3.0 ed Ecobonus, un mix di incentivi e soluzioni impiantistiche per una progettazione sostenibile. Si parlerà inoltre delle principali soluzioni tecnologiche Daikin: come Hybrizone, il sistema che integra climatizzatori Daikin e radiatori ottimizzando consumi ed emissioni; o il nuovo multisplit che combina climatizzazione aria-aria e riscaldamento idronico oltre alla produzione di acqua calda sanitaria; anche la gamma commerciale sarà protagonista, con Daikin VRV CO2, o la gamma Small Inverter Chiller caratterizzata dall’impiego di diversi refrigeranti. Ma le novità non si limiteranno ai prodotti, verranno illustrate anche le numerose iniziative Daikin, e molto altro.
“Organizzeremo circa 40 eventi in tutta Italia per un momento di incontro con tecnici e installatori, sarà l’occasione per presentare le novità Daikin, ma anche per condividere idee e aggiornamenti sulle più recenti tecnologie e novità normative di settore – commenta Hiroshi Shimada, CEO e Presidente di Daikin -. Il ritmo del cambiamento è sempre più rapido e la comunicazione diretta assume un ruolo fondamentale. Lo scorso anno abbiamo coinvolto circa 10.000 persone, tra installatori e progettisti, confermando il forte bisogno di aggiornamento e l’apporto valoriale di questi incontri. Il nostro obiettivo è continuare a crescere anche nel 2026 e a rafforzare questo dialogo, portando la nostra visione del futuro del settore direttamente sul territorio.”
La partecipazione al Daikin Tour 2026 è gratuita e rappresenta un’opportunità di aggiornamento tecnico, confronto professionale e approfondimento sulle soluzioni più avanzate per la transizione energetica degli edifici.
Per maggiori informazioni e per accreditarsi agli eventi sarà possibile consultare i canali ufficiali Daikin dedicati al Tour 2026.
Per maggiori informazioni e per accreditarsi agli eventi è possibile visitare i link seguenti:
Progettisti: http://www.daikin-eventi.it/tour-2026
Installatori: https://www.daikin-eventi.it/tour-2026-installatori

Daikin
Daikin Industries, Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria per applicazioni residenziali, commerciali, alberghieri e industriali. Fondata nel 1924. Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. Fondata nel 2002, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. conta oggi tre sedi operative distribuite sul territorio nazionale dove conta circa 300 dipendenti. La sede principale, in Via Ripamonti a Milano, ospita tutte le funzioni direzionali, mentre a Genova si trova il Dipartimento Tecnico e di Formazione e a Roma la sede dedicata al supporto delle attività nel centro e sud Italia. Daikin vanta in Italia una presenza industriale, commerciale e di ricerca e sviluppo particolarmente solida, che copre l’intera catena del valore delle soluzioni per il comfort ambientale, la refrigerazione e l’automazione industriale. Il Gruppo opera nel Paese attraverso diverse società specializzate: Daikin Air Conditioning Italy SpA, responsabile della commercializzazione delle soluzioni HVAC per i mercati residenziale e commerciale; Daikin Applied Europe SpA, polo europeo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di sistemi HVAC di grande capacità; Zanotti SpA, attiva nella ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni per la refrigerazione lungo l’intera catena del freddo; Landi SpA, specializzata nella consulenza, progettazione e realizzazione di impianti elettrici, meccanici e HVAC; Duplomatic MS SpA, focalizzata su soluzioni di controllo del movimento e automazione industriale; e AHT Italy SRL, dedicata alla commercializzazione di sistemi di refrigerazione commerciale.
Canone TV, entro il 31 gennaio la dichiarazione per evitare l’addebito in bolletta nel 2026
- Gen 21, 2026
Il conto alla rovescia è iniziato: i contribuenti che non detengono un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione sostitutiva necessaria a ottenere l’esonero dal canone tv per l’intero 2026.
La regola è chiara: chi è intestatario di un’utenza elettrica residenziale e non ha alcun televisore in casa — né proprio né di un componente della famiglia anagrafica — deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate per evitare l’addebito automatico in bolletta. Dal 1° febbraio al 30 giugno sarà comunque possibile presentare la stessa dichiarazione, ma l’esonero varrà soltanto per il secondo semestre dell’anno.
La procedura può essere completata online, attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia, tramite un intermediario abilitato, con posta elettronica certificata oppure inviando una raccomandata senza busta all’Ufficio Canone TV della Direzione Provinciale I di Torino.
Nel modello, il contribuente deve compilare il quadro A, dichiarando sotto la propria responsabilità — ai sensi del Dpr 445/2000 — l’assenza di televisori in tutte le abitazioni collegate alle sue utenze elettriche. Anche gli eredi possono presentare la dichiarazione per utenze ancora intestate a persone decedute.
La scadenza non è una tantum: l’esonero va richiesto ogni anno. Le tempistiche determinano la validità della dichiarazione. Chi invia il modulo tra il 1° luglio e il 31 gennaio ottiene l’esonero per l’intero anno successivo; chi lo presenta tra il 1° febbraio e il 30 giugno evita il pagamento solo per il secondo semestre.
Una regola che vale anche per chi attiva una nuova utenza elettrica: in questo caso la dichiarazione deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo all’attivazione per evitare l’addebito fin da subito.
Esiste poi un’altra casistica frequente: quella dei contribuenti che hanno un’utenza elettrica residenziale ma appartengono a una famiglia anagrafica in cui il canone è già pagato da un altro componente. Anche in questo caso è necessario comunicarlo all’Agenzia, compilando il quadro B del modello e indicando il codice fiscale del soggetto che versa il tributo e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia. La data è determinante: se coincide con il 1° gennaio dell’anno di presentazione, il canone non è dovuto per l’intero anno; se è successiva, cambiano gli effetti sul primo e sul secondo semestre.
Le condizioni dichiarate, naturalmente, possono mutare. L’acquisto di un televisore o la cessazione dello stato di famiglia precedentemente comunicato devono essere segnalati tempestivamente compilando il quadro C. In questi casi, il canone torna ad essere addebitato a partire dal mese di presentazione della nuova dichiarazione.
Per orientarsi tra moduli, scadenze e casi particolari, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una sezione dedicata al canone tv con risposte ai quesiti più frequenti. Ma una cosa è certa: chi intende evitare l’addebito per il 2026 deve agire ora, prima che il calendario chiuda la finestra utile.
Il Milleproroghe sposta l’obbligo della copertura assicurativa per gli eventi catastrofali
- Gen 20, 2026
Il termine per mettersi in regola ed evitare che la mancata stipula della polizza contro gli eventi catastrofali comporti l’esclusione dall’accesso a contributi pubblici, previsto per il primo gennaio del 2026, è ora rimandato al 31 marzo 2026.
Lo ha stabilito dal decreto-legge “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre.
La Legge di Bilancio 2024 aveva introdotto l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali, cioè polizze assicurative che coprano i danni causati alle imprese dalle calamità naturali, per non gravare eccessivamente sullo Stato che, in presenza di alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane, è chiamato a stanziare fondi per ripristinare la funzionalità delle imprese e degli stabilimenti produttivi.
Inizialmente, l’obbligo di dotarsi delle polizze catastrofali sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 marzo 2025.
Tuttavia, il regolamento con le indicazioni operative, le modalità attuative e gli schemi di assicurazione (DM 18/2025), pubblicato il 27 febbraio 2025, ha di fatto lasciato alle imprese poco tempo per adeguarsi alle nuove regole.
Il Governo, quindi, per andare incontro alle richieste degli operatori, ha prorogato l’entrata in vigore dell’obbligo con il DL 39/2025.
La legge di conversione del DL 39/2025 ha previsto un avvio a scaglioni: per le grandi imprese un periodo transitorio di 90 giorni rispetto all’obbligo dal 1° aprile 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno 2025) e tempi più lunghi per le altre.
Se per le medie imprese l’obbligo è scattato il 1° ottobre, piccole e micro imprese avrebbero dovuto adeguarsi entro il 1° gennaio 2026, prima dell’ultimo rinvio disposto dal decreto.
Si ricorda che la normativa sull’obbligo di polizze catastrofali non è risultata subito chiara.
Lo scorso aprile, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una serie di Faq per rispondere alle incertezze degli operatori sul decreto legge, ad esempio in merito all’obbligo di stipulare le polizze catastrofali per gli edifici con abusi edilizi.
La legge di conversione del decreto, approvata a fine maggio, ha ripreso alcuni argomenti trattati nelle Faq, dando loro la certezza di una norma.
In materia di abusi edilizi, la legge di conversione ha spiegato che possono essere assicurati gli immobili:
• costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio;
• la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
• oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Il Decreto Sicurezza sul Lavoro è legge
- Gen 14, 2026
La Camera dei Deputati ha approvato il 18 dicembre 2025 il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 159/2025, noto come “Decreto Sicurezza sul Lavoro”. Il provvedimento, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un pacchetto di misure pensate per rafforzare la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, con un focus particolare sul settore dell’edilizia e sulle figure tecniche che operano nei cantieri.
Il decreto si muove lungo due direttrici principali: da un lato, incentiva le imprese che investono in sicurezza, premiando i datori di lavoro virtuosi con agevolazioni e accesso preferenziale a bandi pubblici; dall’altro, potenzia l’apparato ispettivo e sanzionatorio, prevedendo controlli più serrati e sanzioni più severe per chi non rispetta le normative. Tra le novità, anche l’introduzione di badge digitali per il tracciamento delle presenze in cantiere, obblighi formativi più stringenti e aggiornamenti sui rischi legati allo stress lavoro-correlato.
L’urgenza di un intervento normativo è confermata dai numeri: secondo i dati Inail, nel 2025 sono stati denunciati 497.341 infortuni sul lavoro, in aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Ancora più preoccupante è il dato sulle morti: 896 decessi nei primi dieci mesi dell’anno, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2024. Le malattie professionali, inoltre, sono cresciute del 10,2%, raggiungendo quota 81.494 casi.
Le reazioni delle associazioni di categoria non si sono fatte attendere. L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) ha definito il 2025 “l’anno delle occasioni perse”, sottolineando come le misure approvate siano un passo avanti, ma non ancora sufficienti a invertire la tendenza. I sindacati, pur apprezzando l’impianto del decreto, chiedono maggiori risorse per gli ispettorati del lavoro e un piano straordinario di assunzioni per garantire controlli efficaci e capillari.
Il Decreto Sicurezza sul Lavoro si inserisce in un contesto complesso, in cui la sicurezza continua a essere una delle grandi emergenze del mondo produttivo italiano. La sua efficacia dipenderà non solo dalla qualità delle norme, ma dalla loro concreta applicazione. Perché la sicurezza non può restare sulla carta: deve diventare cultura diffusa, responsabilità condivisa e priorità politica.
Bonus bollette 2026, Arera aggiorna gli importi
- Gen 12, 2026
L’Arera ha stabilito gli importi dei bonus sociali per il 2026, confermando le agevolazioni destinate alle famiglie con Isee basso e ai nuclei con persone affette da gravi patologie che richiedono apparecchiature elettromedicali. Con il nuovo anno è terminato anche il contributo straordinario introdotto nel 2025 per chi aveva un Isee fino a 25 mila euro.
Per accedere ai bonus restano validi i requisiti: Isee fino a 9.530 euro, oppure fino a 20 mila euro per le famiglie con almeno quattro figli. Il beneficio, una volta riconosciuto, dura 12 mesi.
Bonus elettrico 2026
• 1-2 componenti: 146 euro
• 3-4 componenti: 186,15 euro
• Oltre 4 componenti: 204,40 euro
Bonus gas 2026
Importi variabili per zona climatica, numero di componenti e utilizzo del gas.
Si va da un minimo di 39,16 euro fino a un massimo di 156,45 euro nelle aree più fredde per i nuclei più numerosi.
Bonus per disagio fisico
Tre fasce basate sull’extraconsumo elettrico:
• Fascia minima: 142,35–208,05 euro
• Fascia media: 284,70–335,80 euro
• Fascia massima: 423,40–463,55 euro
Legionella: proteggi i tuoi impianti idrici prevenendo la proliferazione del batterio
- Gen 9, 2026
La Legionella è un rischio serio per la salute pubblica, soprattutto in ambienti con impianti idrici complessi come piscine, centri sportivi, strutture ricettive e sanitarie oltre che complessi condominiali.
Per prevenire la proliferazione di questo batterio, è fondamentale affidarsi a un piano di controllo professionale, che includa:
• Analisi del Rischio
• Analisi microbiologiche
• Manutenzione documentata
• Sistemi di disinfezione efficaci
Ecco le soluzioni Grundfos Water Treatment:
Offriamo diverse tecnologie affidabili per la disinfezione dell’acqua:
• BIOSSIDO DI CLORO: una delle soluzioni più sicure ed efficaci oggi disponibili, 10 volte più potente dei disinfettanti tradizionali.
• MONOCLORAMMINA: ideale per impianti complessi, la monoclorammina risulta molto stabile e a lento rilascio che permette la permanenza del prodotto per un tempo prolungato riuscendo a raggiungere anche i punti più distanti con un effetto meno aggressivo per i materiali.
• PEROSSIDO DI IDROGENO: si tratta di una soluzione concentrata a base di acqua ossigenata biocida, facilmente dosabile e inodore. Prodotto conforme PT5 per l’utilizzo sulle acque destinate al consumo umano
• MICROFILTRAZIONE: attraverso una barriera meccanica (filtro assoluto da 0,2 micron) appartenenti alla categoria dei Dispositivi Medici in classe I oppure II, è possibile rimuovere la legionella dall’acqua al punto di utilizzo; si tratta di un sistema localizzato, facile da installare ed efficiente, che richiede la sostituzione periodica dei filtri a causa del progressivo intasamento.*
• Impianti UV: la luce ultravioletta è in grado di inattivare i batteri in modo da ostacolarne la replicazione, è possibile installare più impianti nei vari punti d’uso, questo limita notevolmente le potenzialità dell’applicazione di questa tecnologia.
*Per una maggiore efficienza si consiglia l’installazione dei filtri in prossimità del punto d’uso e oltre ad una sostituzione periodica.
Il nostro servizio post-vendita garantisce:
• Installazione e collaudo dei sistemi
• Analisi da laboratori accreditati
• Contratti di manutenzione personalizzati
Come orientarsi tra le tante soluzioni anti legionella? Fatti aiutare da un professionista dell’acqua!
Con Grundfos Water Treatment, hai al tuo fianco un team di esperti e consulenti in grado di valutare i rischi e garantire soluzioni durature.
Contattaci subito per fissare un appuntamento con i nostri professionisti.
Grundfos Water Treatment Italy S.r.l.
Via Gandolfi, 6 – 40057Cadriano di Granarolo dell’Emilia
info.it@grundfoswt.com
sito web: www.grundfos.it/wt


Pompe di calore geotermiche: efficienza e innovazione nella climatizzazione
- Gen 8, 2026
Le pompe di calore geotermiche rappresentano una soluzione all’avanguardia nel mondo della climatizzazione sostenibile, sfruttando il calore naturale del sottosuolo per garantire comfort termico in ogni stagione. Questo sistema si distingue per la sua efficienza energetica, garantendo riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (ACS) con un impatto ambientale ridotto.
Come funziona un impianto geotermico
Un impianto geotermico è composto da tre elementi fondamentali:
– Pompa di calore, il cuore del sistema che gestisce lo scambio termico;
– Serbatoio di accumulo, per immagazzinare energia termica;
– Bollitore per ACS presente nei sistemi che prevedono la produzione di acqua calda.
A differenza dell’aria esterna, soggetta a variazioni stagionali, il sottosuolo mantiene una temperatura costante. Questo consente alla pompa di calore di sfruttare al meglio lo scambio termico:
– In inverno, il calore viene estratto dal terreno e trasferito agli ambienti interni;
– In estate, il calore in eccesso viene ceduto al sottosuolo, garantendo un raffrescamento naturale.
Tipologie di pompe di calore geotermiche
Le pompe di calore geotermiche si distinguono in:
– Sistema acqua-acqua (aperto), che utilizza l’energia termica delle acque di falda;
– Sistema terra-acqua (chiuso), che sfrutta il calore del suolo senza prelievo diretto di acqua.
Nel sistema aperto l’acqua viene prelevata da un pozzo e, una volta raffreddata, reimmessa nel sottosuolo. Nel sistema chiuso, invece, il fluido termovettore circola all’interno di tubazioni interrate, garantendo continuità e stabilità termica senza consumare risorse idriche.
Sistemi chiusi: configurazioni impiantistiche
I sistemi geotermici chiusi possono essere realizzati con diverse configurazioni:
– Sonde verticali, inserite in perforazioni profonde che massimizzano lo scambio termico, ideali per spazi limitati;
– Sonde orizzontali, disposte a pochi metri di profondità, preferibili in aree con ampie superfici libere;
– Scambio termico con acqua di falda, dove l’acqua sotterranea viene impiegata come fluido termovettore senza prelievo diretto;
– Sonde geotermiche integrate nelle strutture di fondazione, un’innovativa soluzione per ottimizzare il rendimento energetico;
– Geostrutture, con sonde installate in elementi strutturali che combinano funzione portante e scambio termico.
Un futuro più sostenibile con la geotermia
Grazie alla sua resa costante e alla possibilità di ridurre le emissioni di CO₂, la geotermia si conferma una tecnologia ideale per edifici civili e terziari, offrendo comfort ed efficienza con un basso impatto ambientale. Il suo utilizzo è destinato a crescere, diventando una delle soluzioni più promettenti per il riscaldamento e la climatizzazione del futuro.
Caldaie, addio ai controlli in casa: la riforma che fa discutere
- Dic 18, 2025
Niente più ispezioni nelle abitazioni. È questa la novità più controversa contenuta nella bozza del nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), che punta a riscrivere le regole sui controlli degli impianti termici, mandando in pensione il Dpr 74 del 2013. Una riforma presentata come un’operazione di “semplificazione”, ma che secondo l’Unione Artigiani di Milano e Monza Brianza potrebbe trasformarsi in un boomerang: meno sicurezza, più inquinamento, e costi occulti per la collettività.
A far scattare l’allarme è l’articolo 8, comma 3, del nuovo schema normativo: stop alle ispezioni “in situ” per tutti gli impianti sotto i 70 kW. Tradotto: circa 20 milioni di caldaie domestiche a gas — di cui almeno 7 milioni con oltre 15 anni di vita — non saranno più controllate direttamente nelle case. Al loro posto, solo verifiche documentali a distanza.
Una scelta che, sulla carta, promette efficienza amministrativa. Ma nella realtà italiana, dove i catasti degli impianti termici sono frammentati, le piattaforme digitali non dialogano tra loro e i dati non si incrociano con quelli delle forniture di gas o delle anagrafi, il rischio è quello di affidarsi a un’infrastruttura che semplicemente non esiste.
«Controlli da scrivania? Oggi sono una chimera», denuncia Marco Accornero, segretario generale dell’Unione Artigiani. «Si vuole alleggerire un costo per le famiglie, ma lo si fa a scapito della sicurezza e dell’ambiente».
Il decreto fissa anche un nuovo standard minimo nazionale: un solo controllo di efficienza energetica ogni quattro anni. Le Regioni potranno alzare l’asticella, ma solo con “motivazioni robuste”. Un freno, secondo gli artigiani, per quei territori virtuosi che hanno investito in sistemi di monitoraggio avanzati. Come la Lombardia, dove ogni anno viene ispezionato il 5% degli impianti, con risultati tangibili in termini di sicurezza, emissioni e risparmio.
Ma c’è di più. I dati del Comitato Italiano Gas parlano chiaro: tra il 2019 e il 2023 si sono registrati 1.119 incidenti legati al gas canalizzato per usi civili, con 128 morti e 1.784 feriti. Numeri che raccontano una realtà fatta di impianti vetusti e manutenzioni carenti, non certo di burocrazia superflua.
E poi c’è il nodo ambientale. A Milano, ogni inverno, l’accensione dei riscaldamenti coincide con il superamento dei limiti di polveri sottili. Ridurre i controlli significa accettare caldaie obsolete, più emissioni e più sprechi. Un paradosso, proprio mentre si parla di transizione ecologica e risparmio energetico.
Per questo l’Unione Artigiani lancia un appello al governo: «Fermatevi. Riconsiderate il testo. Dietro la parola “semplificazione” si nasconde una scelta che pesa sulla salute, sull’ambiente e sulla sicurezza di milioni di famiglie».
TARI 2026, arriva il bonus sociale: sconto automatico del 25% per le famiglie con ISEE basso
- Dic 18, 2025
A partire dal 2026, le famiglie economicamente svantaggiate potranno beneficiare di uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti (TARI), grazie all’introduzione del nuovo bonus sociale previsto dalla delibera Arera 355/2025/R/rif. L’agevolazione, attesa da tempo e ora ufficialmente istituita, si affianca ai bonus già attivi per luce, gas e acqua, e nasce in attuazione del D.L. 124/2019 e del DPCM n. 24/2025.
La TARI, introdotta dalla legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il nuovo bonus, pensato per alleggerire il peso fiscale sulle famiglie in difficoltà, sarà riconosciuto automaticamente ai nuclei con ISEE inferiore a 9.530 euro, oppure sotto i 20.000 euro se con almeno quattro figli a carico. Non sarà necessario presentare alcuna domanda: sarà l’INPS a trasmettere ai Comuni i dati utili per individuare i beneficiari, sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dai cittadini.
Come funziona lo sconto e quando si applica
Il meccanismo del bonus TARI prevede che lo sconto venga applicato sull’importo dovuto nell’anno successivo a quello in cui è stato presentato l’ISEE. In pratica, l’attestazione ISEE 2025 servirà per ottenere lo sconto sulla TARI 2026. Questo perché la tassa rifiuti viene calcolata all’inizio dell’anno, mentre l’ISEE può essere aggiornato in qualsiasi momento. L’agevolazione sarà visibile direttamente nella bolletta, senza ulteriori passaggi burocratici.
L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha chiarito che il bonus si applica solo agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L’etichetta “bonus sociale” garantisce uniformità nazionale, ma non sostituisce le agevolazioni locali già attive. Infatti, molti Comuni prevedono ulteriori sconti o esoneri totali per le famiglie in difficoltà.
Agevolazioni comunali: il caso Roma e le verifiche annuali
Il bonus TARI nazionale si affianca alle misure locali già in vigore. A Roma, ad esempio, i nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.500 euro possono ottenere l’esonero totale dal pagamento della tassa rifiuti. L’Amministrazione capitolina verifica annualmente la validità dell’ISEE tramite la banca dati INPS e, in caso di esito negativo, procede al recupero dell’importo dovuto.
Per sapere se si ha diritto a ulteriori agevolazioni, è consigliabile consultare il sito ufficiale del proprio Comune di residenza. Ogni ente locale può stabilire soglie diverse, modalità di richiesta e documentazione necessaria. Il contribuente può così verificare la corrispondenza tra la propria situazione familiare e i requisiti previsti, evitando sorprese e cogliendo tutte le opportunità di risparmio.
Agibilità degli immobili: quando è obbligatoria, quanto costa e cosa si rischia senza
- Dic 15, 2025
Nel mondo immobiliare, il concetto di agibilità è spesso sottovalutato, ma rappresenta uno dei pilastri normativi per garantire che un edificio sia conforme agli standard di sicurezza, igiene e risparmio energetico. Oggi, il tradizionale certificato è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da presentare al Comune.
Quando è obbligatoria la SCA
La SCA è richiesta per:
– nuove costruzioni;
– interventi su edifici esistenti che modificano le condizioni di sicurezza, salubrità o efficienza energetica;
– cambi di destinazione d’uso;
– ampliamenti significativi.
Non è invece obbligatoria per gli immobili costruiti prima del 1934, esonerati dalla normativa.
Durata e decadenza
La SCA non ha una scadenza temporale. Resta valida fino a quando non intervengono modifiche strutturali o cambi di destinazione d’uso. In questi casi, è necessario presentare una nuova segnalazione per mantenere la conformità alle normative.
Cosa si rischia senza agibilità
Un immobile privo di agibilità può essere considerato non abitabile. Le conseguenze includono:
– sanzioni amministrative;
– impossibilità di vendere o affittare legalmente;
– invalidazione di contratti e potenziali richieste di risarcimento;
– difficoltà nell’ottenere polizze assicurative.
La SCA va presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori. In caso di ritardo, sono previste sanzioni da 77 a 464 euro.
Quanto costa ottenere l’agibilità
Il costo varia in base alla tipologia e dimensione dell’immobile. Le principali voci di spesa includono:
– costi di segreteria (circa 150 euro);
– marche da bollo (16 euro ciascuna);
– onorario del tecnico (da 120 a oltre 1.500 euro);
– eventuale collaudo statico.
In totale, la spesa può oscillare tra 400 e 4.000 euro.
Come verificare l’agibilità di un immobile
Per accertarsi che un immobile sia dotato di agibilità, è possibile:
– consultare l’Archivio delle Licenze di Agibilità presso il Comune;
– richiedere il documento al proprietario o al tecnico incaricato.