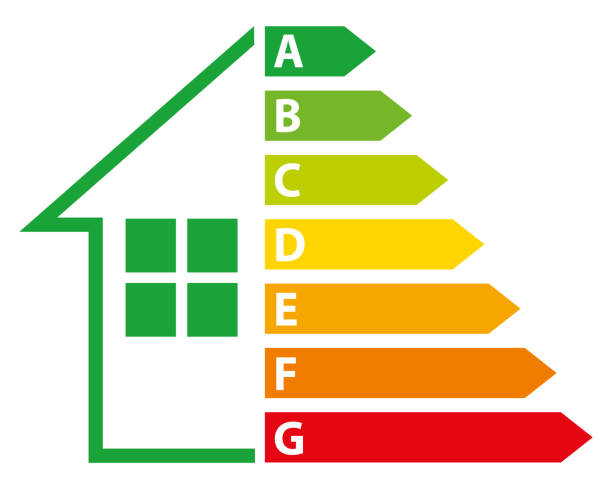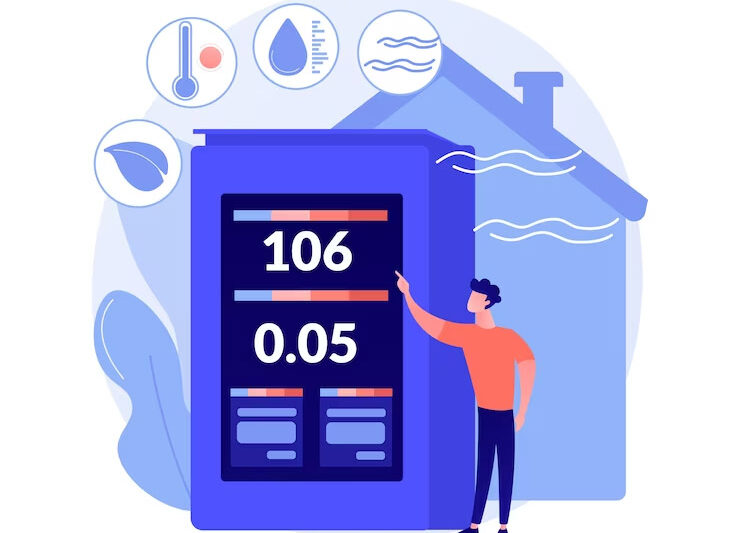ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
Confedilizia: bene i fondi UE per la casa, ma il vero nodo resta il rafforzamento dell’affitto privato
Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2026 da parte del Parlamento, dal 1º gennaio sono entrate in vigore numerose misure in materia economica e fiscale. Tra queste figurano la proroga dei bonus edilizi, la nuova rottamazione e diversi interventi sul fronte abitativo. Il pacchetto è stato accolto con favore da Confedilizia, l’associazione che rappresenta i proprietari immobiliari, che ha espresso un giudizio complessivamente positivo soprattutto per quanto riguarda l’intesa raggiunta tra Governo e Regioni sull’utilizzo dei fondi europei destinati alla casa.
Pur riconoscendo l’importanza di queste risorse, l’associazione sottolinea però la necessità di un intervento più incisivo per rilanciare il mercato della locazione privata, ritenuto un tassello imprescindibile per ampliare rapidamente l’offerta abitativa.
Fondi UE per alloggi a prezzi accessibili: un’opportunità significativa
Nel giorno stesso dell’approvazione della manovra, Confedilizia ha diffuso una nota in cui evidenzia la portata dell’accordo tra Governo e Regioni: oltre 1 miliardo di euro provenienti dalla revisione dei programmi di coesione europei sarà destinato alla creazione di alloggi sostenibili e a prezzi calmierati.
Si tratta di risorse che, sommate agli altri strumenti già attivi nell’ambito delle politiche di coesione, portano a circa 3,1 miliardi di euro l’impegno complessivo dell’Unione Europea sul fronte abitativo. Un volume finanziario rilevante, che secondo l’associazione può contribuire a dare una risposta strutturale alla crescente domanda di case accessibili, soprattutto nelle aree urbane dove il disagio abitativo è più marcato.
Confedilizia: “Serve un vero rilancio della locazione privata”
Accanto agli investimenti pubblici, Confedilizia richiama però l’attenzione su un altro elemento che ritiene decisivo: il rafforzamento del mercato dell’affitto privato.
Secondo l’associazione, questo segmento può garantire in tempi molto più rapidi rispetto all’edilizia pubblica un aumento dell’offerta di abitazioni a canoni sostenibili, a condizione che venga adeguatamente sostenuto. Le richieste avanzate al Governo puntano in particolare su due leve:
• incentivi fiscali, con una riduzione della pressione tributaria sugli immobili locati, inclusa una revisione dell’Imu;
• maggiore certezza giuridica, attraverso procedure di sfratto più rapide ed efficaci, ritenute indispensabili per ridurre il rischio percepito dai proprietari.
Confedilizia sostiene che solo intervenendo su questi aspetti sarà possibile mobilitare una parte significativa del patrimonio immobiliare oggi inutilizzato o sottratto al mercato.
Le osservazioni sulla manovra di bilancio
Nel valutare la legge di bilancio, l’associazione formula due considerazioni principali.
Da un lato, giudica positivamente il rinnovo annuale delle detrazioni edilizie così come configurate per il 2025, pur ribadendo la necessità di definire un quadro stabile e pluriennale che consenta a famiglie e imprese di programmare gli interventi senza incertezze normative.
Dall’altro, apprezza la decisione del Governo di non procedere all’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi relativi alla prima casa, dopo l’inasprimento già introdotto due anni fa per le altre tipologie. Tuttavia, Confedilizia critica con forza l’obbligo di adottare la forma imprenditoriale per chi destina più di due immobili alla locazione breve: una misura ritenuta non solo discutibile dal punto di vista giuridico-tributario, ma anche potenzialmente dannosa per i territori più fragili.
Secondo l’associazione, infatti, tale vincolo rischia di penalizzare ulteriormente le aree interne e i borghi già colpiti dallo spopolamento, dove l’attività di locazione turistica rappresenta spesso una delle poche leve rimaste per stimolare economia e presenza abitativa.
Assemblea condominiale: l’amministratore è il protagonista o soltanto una comparsa?
- Feb 12, 2026
Parlando di assemblea condominiale si dà spesso per scontata la presenza dell’amministratore di condominio, ma a tal proposito è importante chiarire che da un punto di vista normativo non esiste alcuna norma vigente che faccia riferimento all’obbligo dell’amministratore di condominio di presenziare all’assemblea condominiale.
L’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile stabilisce che l’assemblea va convocata con scadenza annuale dall’amministratore ma riguardo l’obbligo della sua partecipazione, all’interno della norma, non vi è alcun accenno.
A tal proposito, non vi è alcun riferimento in tal senso neanche nell’art. 1136 del Codice civile che regola la costituzione dell’assemblea e la validazione delle deliberazioni.
È dunque chiaro che da un punto di vista normativo la presenza dell’amministratore di condominio alle assemblee non è obbligatoria ma, ovviamente, è sempre opportuna, poiché l’amministratore è di fatto la persona che conosce meglio le dinamiche e le problematiche del condominio, inoltre solo l’amministratore è in possesso delle ricevute delle convocazioni, pertanto è in grado di certificare la regolarità della costituzione assembleare.
Inoltre, l’amministratore è solitamente in possesso del registro dei verbali d’assemblea e conosce esattamente i millesimi di proprietà di ogni condomino, ciò significa che può rilevare il rispetto del quorum.
Riguardo le altre due figure generalmente presenti alle assemblee di condominio, ovvero il presidente dell’assemblea che ha la funzione di dirigere l’assemblea e il segretario, che è un coadiuvante dell’assemblea incaricato di redigere il verbale, da un punto di vista normativo non esiste alcun obbligo che detti la necessità di tali figure, anche se ovviamente è sempre consigliabile consultare il regolamento di condominio il quale potrebbe imporre la presenza di un presidente e di un segretario.
Tornando alla partecipazione in assemblea dell’amministratore, è pur vero che nonostante non esista un obbligo normativo, la sua presenza può ugualmente costituire una necessità per una consapevole deliberazione, in quanto egli è depositario di tutti i documenti giustificativi ed è l’unico che può dimostrare le spese sostenute per la manutenzione delle parti comuni e i vari servizi presenti in condominio.
Inoltre, l’amministratore è una figura super partes, pertanto è la persona più indicata per risolvere eventuali controversie tra condòmini.
Nonostante il nostro Codice civile non obblighi l’amministratore a prendere parte alle assemblee condominiali, è bene evidenziare che ad esempio la Corte di Cassazione sezione 2° civile, con la sentenza del 12 marzo 2003 n. 3596 si è espressa in tal senso stabilendo che sebbene tra i compiti dell’amministratore elencati dal Codice civile non sia espressamente menzionata la sua partecipazione alle assemblee, in ragione dei rapporti di diritto tra l’amministratore e l’assemblea, la sua presenza deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali di amministrazione.
Ad ogni modo, se l’amministratore per qualsiasi motivo non si presenta il giorno dell’assemblea, si può agire in vari modi.
In primis si può optare per il rinvio dell’assemblea in altra data da comunicare ai condòmini in un momento successivo. Oppure si può optare per svolgere comunque l’assemblea purché ci sia un sostituto incaricato dall’amministratore, salvo espresso divieto nel regolamento condominiale. Altrimenti una terza opzione è quella che i condòmini decidano ugualmente di tenere l’assemblea senza la presenza né dell’amministratore né del sostituto.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Il registro dell’anagrafe condominiale è obbligatorio
- Feb 4, 2026
Per l’amministratore di condominio è sempre obbligatorio tenere il registro di anagrafe condominiale? In caso di risposta positiva, quali sono i soggetti da censire in base a quale titolo? Proprietà, locazione, uso eccetera?
La risposta è positiva: a norma dell’articolo 1130, n. 6, del Codice civile, l’amministratore ha l’obbligo di tenere il registro di anagrafe condominiale.
Tale registro deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Oltre ai proprietari, dovranno quindi essere censiti gli usufruttuari, i titolari di diritto d’uso o di abitazione, i conduttori (sulla base di un contratto di locazione), i comodatari e i titolari di altri diritti reali o personali.
L’amministratore condominiale, in caso di inerzia di questi soggetti, e di mancanza o incompletezza nella comunicazione di questi dati, deve chiederli con lettera raccomandata.
In mancanza di risposta, decorsi trenta giorni, l’amministratore acquisirà le informazioni necessarie addebitandone il costo direttamente ai responsabili della carenza informativa.
Nuda proprietà, è boom: la vendono gli anziani, la comprano i giovani
- Gen 30, 2026
Negli ultimi anni, la nuda proprietà è diventata uno degli strumenti immobiliari più richiesti in Italia.
La formula permette al venditore di cedere la proprietà dell’immobile, mantenendo però l’usufrutto, ossia il diritto di viverci fino alla fine della propria vita.
Si tratta di una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti:
• Il venditore ottiene liquidità immediata senza dover lasciare casa.
• L’acquirente può acquistare un immobile a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato.
Con il mutare delle esigenze economiche e demografiche, questa modalità di vendita sta diventando una strategia di investimento sempre più diffusa.
Perché la nuda proprietà sta vivendo un boom
• L’invecchiamento della popolazione – In un paese come l’Italia, dove l’aspettativa di vita continua a salire, molti anziani vedono nella nuda proprietà un modo per ottenere liquidità senza perdere la sicurezza della casa.
• Le difficoltà economiche e le pensioni basse – Molti pensionati faticano a mantenere uno standard di vita adeguato, tra aumenti dei costi e pensioni sempre meno generose. Vendere la nuda proprietà consente loro di migliorare la propria condizione finanziaria senza dover abbandonare l’immobile.
• La strategia degli investitori – Gli acquirenti – siano essi privati, fondi immobiliari o giovani investitori – trovano nella nuda proprietà un’opportunità di acquistare immobili a prezzi ribassati, con la prospettiva di entrarne pienamente in possesso in futuro.
• Rapporti familiari tesi: meglio monetizzare che lasciare in eredità – Sempre più anziani, delusi da dinamiche familiari difficili, scelgono di vendere la nuda proprietà per godersi la liquidità mentre sono in vita, invece di lasciare la casa in eredità a parenti con cui non vogliono avere legami. Il concetto di “parenti serpenti” è diventato parte del discorso attorno alla nuda proprietà, con sempre più persone che preferiscono monetizzare il proprio patrimonio piuttosto che alimentare future dispute ereditarie.
Come funziona la compravendita della nuda proprietà
• Il venditore cede la proprietà dell’immobile, ma mantiene il diritto di usufrutto, continuando a viverci.
• L’acquirente paga un prezzo ridotto, determinato dalla valutazione dell’immobile e dall’età del venditore.
• Alla scomparsa del venditore, l’immobile passa definitivamente nelle mani dell’acquirente, libero da vincoli.
Questa formula consente vantaggi economici per entrambe le parti, ma deve essere valutata con attenzione per evitare problematiche future.
Vantaggi e svantaggi della nuda proprietà
La vendita della nuda proprietà offre una serie di benefici, soprattutto per chi desidera ottenere liquidità senza dover rinunciare alla casa in cui vive. Per gli anziani, questa soluzione rappresenta un modo intelligente per migliorare la propria qualità di vita, attingendo a un capitale spesso inutilizzato, mentre continuano a risiedere nell’immobile. Inoltre, un altro aspetto vantaggioso per il venditore è quello legato alla gestione delle spese. Le manutenzioni straordinarie, infatti, diventano una responsabilità dell’acquirente, sollevando il nudo proprietario da oneri spesso onerosi e difficili da affrontare con una pensione ridotta.
Dal lato degli acquirenti, la nuda proprietà si configura come un’opportunità di investimento molto interessante. L’immobile viene acquistato a un prezzo inferiore rispetto al suo valore di mercato, garantendo una futura proprietà a condizioni più vantaggiose rispetto a una compravendita tradizionale. Chi sceglie di acquistare una nuda proprietà solitamente è una persona con una visione a lungo termine, interessata a realizzare un investimento destinato a maturare nel tempo. Questa formula consente di bloccare il prezzo dell’immobile senza la necessità di utilizzarlo subito, il che può risultare strategico per chi non ha urgenza di trovare una casa, ma vuole ampliare il proprio patrimonio immobiliare.
Naturalmente, questa modalità di compravendita presenta anche delle criticità. Per il venditore, il principale svantaggio è quello legato al valore economico dell’operazione: il prezzo di vendita è più basso rispetto a una normale cessione della proprietà, perché l’acquirente deve aspettare prima di poter usufruire pienamente dell’immobile. Inoltre, una volta ceduta la nuda proprietà, il venditore perde la possibilità di utilizzare l’abitazione come garanzia per eventuali necessità future, come un prestito o un’ulteriore transazione economica.
Dal punto di vista dell’acquirente, la principale sfida consiste nell’incertezza legata ai tempi di acquisizione definitiva dell’immobile. Non essendo possibile prevedere con esattezza quando l’usufrutto cesserà, l’investimento potrebbe rimanere immobilizzato per anni senza possibilità di utilizzo. Inoltre, nel periodo in cui l’usufruttuario continua a vivere nella casa, l’acquirente non ha alcun potere decisionale sul bene e deve comunque farsi carico delle spese straordinarie di manutenzione.
La nuda proprietà, quindi, è una soluzione che offre molte possibilità, ma che richiede un’attenta valutazione per comprendere se possa davvero essere vantaggiosa in base alle proprie esigenze. Per chi vende, rappresenta una via per ottenere liquidità immediata senza dover lasciare la propria casa; per chi acquista, è un investimento che può rivelarsi molto redditizio nel tempo, sebbene con alcune incognite legate alla sua effettiva fruizione. Come in ogni operazione immobiliare, la chiave sta nella consapevolezza delle condizioni e nella pianificazione di lungo periodo.
Il profilo del venditore: chi sceglie la nuda proprietà
In Italia, chi vende la nuda proprietà è spesso un anziano pensionato che:
• Non ha eredi o non vuole lasciare la casa a figli e parenti.
• Vuole liquidità immediata per vivere meglio.
• Desidera eliminare la responsabilità delle spese straordinarie dell’immobile.
Il fenomeno è particolarmente diffuso nelle grandi città, dove il valore degli immobili è alto e la possibilità di ottenere una somma significativa dalla vendita è concreta.
Il profilo dell’acquirente: chi compra la nuda proprietà?
Gli acquirenti della nuda proprietà rientrano in diverse categorie:
• Giovani investitori, che puntano su un’operazione a lungo termine.
• Fondi immobiliari, che diversificano il portafoglio con questa formula.
• Famiglie con disponibilità economica, che acquistano oggi per avere un immobile in futuro.
Il mercato della nuda proprietà: numeri e tendenze
• Il volume delle transazioni di nude proprietà è aumentato di oltre il 20% negli ultimi cinque anni.
• Le città principali per questo mercato sono Milano, Roma, Firenze e Torino.
• Gli acquirenti sono sempre più spesso fondi immobiliari o giovani investitori.
Questi dati dimostrano che la nuda proprietà è una formula sempre più utilizzata, sia come soluzione per gli anziani sia come strategia per gli investitori.
Le prospettive future della nuda proprietà in Italia
Guardando al futuro, la nuda proprietà sembra destinata a consolidarsi sempre più come una soluzione chiave nel mercato immobiliare italiano. La combinazione di fattori economici e demografici sta creando le condizioni perfette per la sua diffusione, e il trend attuale suggerisce che il fenomeno continuerà a espandersi nei prossimi anni.
Uno degli elementi che guiderà questa crescita è l’evoluzione dei prodotti finanziari legati alla nuda proprietà. Le banche e gli istituti di credito stanno iniziando a proporre strumenti specifici per agevolare queste operazioni, sia dal lato dei venditori che degli acquirenti. Potrebbero nascere formule più flessibili, come la possibilità di ottenere prestiti garantiti dalla nuda proprietà, fornendo agli anziani un’alternativa alle classiche rendite pensionistiche.
Parallelamente, il contesto socioeconomico italiano suggerisce che sempre più persone potrebbero valutare questa soluzione per ottenere liquidità. Il costo della vita è in aumento, e la difficoltà nel mantenere uno standard elevato durante la pensione potrebbe spingere una fetta crescente di proprietari a vendere la nuda proprietà per assicurarsi una maggiore tranquillità economica. In un’epoca in cui il possesso di un immobile è visto sempre meno come una sicurezza e sempre più come un capitale immobilizzato, la nuda proprietà offre un modo per monetizzare il proprio patrimonio senza dover rinunciare alla propria abitazione.
Dal lato degli acquirenti, invece, la formula potrebbe diventare ancora più appetibile, grazie alla professionalizzazione del settore. Fondi immobiliari, società di investimento e grandi gruppi stanno dimostrando un crescente interesse per questa tipologia di operazione, vedendola come un modo efficace per diversificare i propri portafogli. Non è da escludere che, in futuro, possano svilupparsi nuove strategie di gestione, come la possibilità di mettere a reddito immobili in nuda proprietà attraverso affitti a lungo termine con l’usufruttuario.
Infine, un aspetto che potrebbe dare un ulteriore slancio al mercato è la maggiore informazione e consapevolezza da parte dei venditori e degli acquirenti. In passato, la nuda proprietà era una soluzione poco considerata, spesso vista come un’operazione marginale. Oggi, invece, con una maggiore diffusione e con casi di successo sempre più numerosi, la percezione sta cambiando. Il fatto che questa formula immobiliare sia entrata a pieno titolo nel dibattito sugli strumenti finanziari per gli anziani e sugli investimenti immobiliari dimostra che il fenomeno non è più circoscritto a pochi casi sporadici, ma è destinato a diventare una componente sempre più rilevante del mercato immobiliare italiano.
La nuda proprietà è destinata a crescere ancora, grazie a:
• Nuovi prodotti finanziari delle banche.
• Aumento della vita media e delle difficoltà pensionistiche.
• Strategie di investimento più sofisticate da parte di privati e istituzioni.
Se le tendenze attuali saranno confermate, la nuda proprietà diventerà una delle formule immobiliari più rilevanti nei prossimi anni.
Conclusione
Il boom della nuda proprietà è il riflesso di una società in cambiamento. Se da un lato è una risorsa per gli anziani, dall’altro rappresenta un’opportunità per gli investitori. Questa forma di compravendita continuerà a espandersi, diventando una componente strategica del mercato immobiliare italiano.
Edifici: dal 2026 cambia tutto per l’efficienza energetica
- Gen 30, 2026
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed entrante in vigore dal 3 giugno 2026, segna una svolta decisiva per il settore immobiliare italiano.
Il provvedimento, atteso da anni, aggiorna le regole sulle prestazioni energetiche degli edifici, allineando l’Italia alle più recenti direttive europee e introducendo criteri più stringenti per chi costruisce, ristruttura o gestisce immobili.
Sostituisce il DM 26 giugno 2015 e recepisce le direttive europee sull’efficienza energetica (EPBD IV), con l’obiettivo di ridurre i consumi, aumentare l’uso di fonti rinnovabili e avvicinare il patrimonio edilizio italiano alla neutralità climatica entro il 2050.
Nuove regole per chi ristruttura o costruisce
Il decreto impone standard più elevati per la progettazione e la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare:
• Nuovi limiti di trasmittanza termica per pareti, tetti, pavimenti e serramenti, con valori più bassi per ridurre le dispersioni di calore. Questo significa che per ottenere l’APE o accedere agli incentivi, i materiali isolanti dovranno essere più performanti.
• Maggiore attenzione ai ponti termici, con obbligo di correzione nei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione importante.
• Obblighi di predisposizione per la mobilità elettrica, come l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli nei parcheggi condominiali.
• Valorizzazione dell’energia prodotta in loco, ad esempio da impianti fotovoltaici, che potrà essere conteggiata nel bilancio energetico dell’edificio.
Le nuove regole si applicano su:
• Nuove costruzioni
• Ristrutturazioni importanti (interventi su oltre il 25% dell’involucro)
• Riqualificazioni energetiche
• Edifici pubblici e privati, residenziali e non residenziali
Per i proprietari che intendono ristrutturare, queste novità significano dover rispettare parametri più severi per accedere agli incentivi e ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Per gli amministratori di condominio, sarà fondamentale aggiornare le pratiche e i capitolati tecnici in vista di lavori su parti comuni.
Impianti termici: nuovi standard
• I nuovi impianti dovranno rispettare limiti più severi di rendimento e di emissioni.
• È incentivata l’adozione di pompe di calore, sistemi ibridi e impianti a bassa temperatura.
• Le caldaie a gas potranno essere installate solo se rispettano i nuovi requisiti Ecodesign e se non sono disponibili alternative tecnicamente fattibili.
APE: cambia il calcolo, cambia la classe
Il nuovo decreto modifica anche i criteri di calcolo dell’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica.
Le classi energetiche saranno ricalibrate per riflettere meglio le reali prestazioni degli edifici, con un focus maggiore sul fabbisogno energetico globale e sull’uso di fonti rinnovabili.
Questo significa che molti edifici potrebbero “scalare” verso il basso nella classificazione, anche senza peggioramenti strutturali.
Un aspetto cruciale per chi intende vendere o affittare, poiché la classe energetica incide direttamente sul valore di mercato e sulla possibilità di accesso a bonus e agevolazioni.
Impatti diretti su condomìni e gestori immobiliari
Per gli amministratori di condominio, il Decreto Requisiti Minimi 2025 introduce nuove responsabilità operative:
• Verificare che ogni intervento edilizio rispetti i nuovi standard.
• Coordinare la predisposizione di colonnine di ricarica elettrica nei parcheggi comuni.
• Aggiornare i regolamenti condominiali e i contratti con fornitori e tecnici.
Inoltre, per gli edifici soggetti a ristrutturazione importante (interventi su oltre il 25 per cento dell’involucro), sarà obbligatorio rispettare requisiti più stringenti anche per gli impianti termici e di ventilazione.
Un passo verso la neutralità climatica
Il decreto si inserisce nel più ampio quadro della Direttiva “Case Green” (EPBD IV), che punta a rendere tutti gli edifici residenziali a emissioni zero entro il 2050. L’Italia, con un parco edilizio tra i più vetusti d’Europa (oltre il 60% degli edifici è stato costruito prima del 1970), è chiamata a uno sforzo straordinario.
Secondo i dati ENEA, oltre 8 milioni di edifici residenziali italiani si trovano oggi in classe energetica F o G. Il nuovo decreto rappresenta quindi uno strumento fondamentale per guidare la riqualificazione e ridurre i consumi, che nel settore residenziale rappresentano circa il 30 per cento del totale nazionale.
In sintesi: cosa devono fare i soggetti coinvolti
• Proprietari immobiliari: verificare la classe energetica del proprio immobile e valutare interventi di riqualificazione per migliorarla.
• Amministratori di condominio: aggiornare le procedure tecniche e normative, informare i condomini e pianificare gli adeguamenti.
• Inquilini: informarsi sui nuovi standard per comprendere meglio i costi energetici e le opportunità di risparmio.
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 non è solo un aggiornamento tecnico: è una chiamata all’azione per tutto il comparto immobiliare. Prepararsi ora significa evitare sorprese, valorizzare il proprio patrimonio e contribuire a un futuro più sostenibile.
Prima casa, attenzione alla decadenza: il preliminare non salva le agevolazioni
- Gen 28, 2026
L’Agenzia delle Entrate chiarisce: in caso di vendita entro cinque anni, il riacquisto dell’abitazione principale deve avvenire con il rogito.
Il contratto preliminare non è sufficiente a evitare la perdita dei benefici fiscali.
Il caso: quando il tempo gioca contro
Un contribuente, dopo aver acquistato un immobile nel 2021 usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, decide di venderlo nel gennaio 2025, quindi prima del termine minimo di cinque anni previsto dalla legge.
Per non perdere i benefici fiscali ottenuti – e soprattutto per evitare la temuta sanzione del 30 peer cento sull’imposta di registro – stipula e registra un contratto preliminare per l’acquisto di una nuova abitazione nel settembre dello stesso anno.
Tuttavia, a causa di ritardi nell’ottenimento del mutuo, teme di non riuscire a firmare il rogito definitivo entro i dodici mesi dalla vendita, cioè entro gennaio 2026.
Da qui nasce il dubbio: il preliminare registrato può bastare per “bloccare” la decadenza? Oppure si può applicare la proroga a due anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025?
Per sciogliere questi nodi, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate, presentando un’istanza di interpello.
La risposta, contenuta nel documento n. 314 del 2025, è chiara e netta: né il preliminare né la proroga possono salvare il beneficio fiscale in questo caso.
L’esame: il preliminare non ha effetti “salvifici”
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, ha richiamato la normativa di riferimento: la Nota II-bis, comma 4, dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Secondo questa disposizione, chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima che siano trascorsi cinque anni deve, per non decadere dal beneficio, acquistare entro un anno un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Ma cosa si intende per “acquisto”?
L’Agenzia ribadisce un principio già espresso nella Circolare n. 18/E del 2013: il contratto preliminare, anche se registrato, non è sufficiente.
Questo perché il preliminare ha natura meramente obbligatoria: impegna le parti a stipulare un futuro contratto definitivo, ma non trasferisce la proprietà dell’immobile.
Solo il rogito – cioè l’atto notarile definitivo – produce l’effetto traslativo richiesto dalla legge.
In altre parole, per evitare la decadenza dalle agevolazioni, non basta dimostrare l’intenzione di acquistare una nuova casa: è necessario che il trasferimento della proprietà sia effettivo e perfezionato entro i dodici mesi dalla vendita del primo immobile.
Se ciò non avviene, il contribuente perde il beneficio e deve restituire le imposte risparmiate, maggiorate di una sanzione del 30% e degli interessi.
Osservazioni: nessuna estensione per analogia
Il secondo punto affrontato dall’Agenzia riguarda la possibilità di estendere il termine per il riacquisto da uno a due anni, sulla base della recente Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).
La manovra, infatti, ha introdotto una modifica al comma 4-bis della stessa Nota II-bis, estendendo da uno a due anni il termine per vendere l’immobile pre-posseduto quando si acquista una nuova “prima casa”.
Il contribuente ha chiesto se questa estensione potesse essere applicata anche al caso inverso, cioè alla vendita dell’immobile agevolato seguita dal riacquisto di una nuova abitazione (comma 4).
Ma anche su questo punto la risposta dell’Agenzia è stata negativa: la proroga riguarda esclusivamente il caso disciplinato dal comma 4-bis, e non può essere estesa per analogia al comma 4.
La distinzione tra le due ipotesi è netta: il comma 4-bis si riferisce al contribuente che acquista una nuova prima casa e ha già un’altra abitazione acquistata con agevolazioni, che deve vendere entro un certo termine per non perdere il beneficio; il comma 4, invece, riguarda chi vende la prima casa prima dei cinque anni e deve riacquistarne un’altra entro un anno.
Due situazioni diverse, due regole diverse.
La posizione dell’Agenzia conferma un orientamento rigoroso, ma coerente con la lettera della legge e con la giurisprudenza prevalente.
Per i contribuenti, il messaggio è chiaro: in caso di vendita infraquinquennale, il riacquisto deve essere effettivo e tempestivo.
Il preliminare non basta, e le proroghe non si applicano se non espressamente previste.
Meglio, dunque, pianificare con attenzione ogni passaggio, soprattutto quando si tratta di tempistiche bancarie e rogiti notarili.
Conto Termico 3.0: incentivi più veloci e digitali. Cosa cambia davvero per chi gestisce immobili
- Gen 26, 2026
Con la delibera 567/2025/R/EFR, approvata il 23 dicembre, Arera ha dato il via libera ai nuovi schemi contrattuali per il Conto Termico 3.0, lo strumento che finanzia interventi di efficienza energetica e produzione di calore da fonti rinnovabili. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’accesso agli incentivi e accelerarne l’erogazione, soprattutto per interventi di piccola e media entità, come quelli che riguardano condomìni, edifici residenziali e impianti centralizzati.
La novità più rilevante? Un sistema a doppio binario per ottenere i contributi: accesso diretto o prenotazione.
Due strade per ottenere gli incentivi: accesso diretto o prenotazione
Il nuovo schema recepisce le indicazioni del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025 e introduce due modalità operative. La prima, l’accesso diretto, è pensata per chi ha già concluso i lavori: la domanda va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’intervento. È la via più rapida per chi ha già investito e vuole recuperare parte della spesa.
La seconda modalità, la prenotazione, è riservata principalmente a Pubbliche Amministrazioni ed ESCO, ma può interessare anche i grandi condomìni. Consente di bloccare l’incentivo prima ancora di iniziare i lavori, con la possibilità di definire le clausole contrattuali in anticipo. Questo significa meno incertezze e tempi più brevi per ricevere i fondi una volta completato l’intervento.
Per gli amministratori di condominio, questa doppia opzione rappresenta un’opportunità concreta per pianificare meglio gli interventi di riqualificazione energetica, scegliendo la formula più adatta alle esigenze del proprio edificio.
Contratti più chiari, pagamenti più rapidi
Il nuovo “contratto tipo” tra il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e il beneficiario ha una durata di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. La prima rata viene erogata entro la fine del mese successivo al bimestre in cui il contratto è stato attivato. Per importi inferiori a 15.000 euro, il pagamento avviene in un’unica soluzione.
Un dettaglio importante per chi gestisce immobili: gli incentivi del Conto Termico 3.0 non sono cumulabili con altri aiuti statali, a meno che non si tratti di edifici pubblici. In quel caso, è possibile arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili combinando più fonti di finanziamento.
È previsto anche un piccolo contributo a carico del beneficiario: l’1% dell’incentivo ricevuto, fino a un massimo di 250 euro, per coprire le spese amministrative e di controllo del GSE.
Tutto digitale: il Portaltermico diventa obbligatorio
Un altro cambiamento cruciale riguarda la gestione delle pratiche. Tutte le comunicazioni, dalla domanda iniziale alla documentazione finale, dovranno passare attraverso il Portaltermico, la piattaforma digitale del GSE. Questo significa addio alla carta e maggiore tracciabilità, ma anche l’obbligo per i soggetti responsabili – spesso gli amministratori di condominio – di conservare con cura tutta la documentazione originale per almeno cinque anni.
Il GSE potrà effettuare controlli a campione o su segnalazione, anche con sopralluoghi. Se emergono irregolarità, perdita dei requisiti o documentazione incompleta, il contratto sarà automaticamente risolto e le somme già erogate dovranno essere restituite.
Un’occasione da non perdere, ma serve attenzione
Il Conto Termico 3.0 rappresenta una leva importante per chi vuole riqualificare il proprio immobile, ridurre i consumi e aumentare il valore dell’edificio. Ma per cogliere davvero i benefici, è fondamentale conoscere le nuove regole, scegliere il canale giusto e rispettare gli obblighi digitali.
Per gli amministratori di condominio, si apre una fase in cui la competenza nella gestione energetica diventa un valore aggiunto. E per i proprietari, è il momento di valutare con attenzione le opportunità offerte da un sistema di incentivi che, finalmente, punta su semplicità, rapidità e trasparenza.
Il Piano Casa europeo: la strategia dell’UE per un abitare accessibile, sostenibile e inclusivo
- Gen 26, 2026
Bruxelles ha rotto gli indugi. Con la presentazione ufficiale del Piano Casa europeo, la Commissione UE ha messo nero su bianco una strategia senza precedenti per affrontare una delle emergenze più pressanti del continente: la crisi dell’abitare.
Un problema che, da Lisbona a Vilnius, da Berlino a Roma, assume contorni sempre più drammatici, con milioni di cittadini europei che faticano a trovare un alloggio accessibile, sostenibile e di qualità.
Una crisi strutturale: numeri che parlano chiaro
Negli ultimi dieci anni, i prezzi delle abitazioni nell’Unione europea sono aumentati in media di oltre il 60 per cento, mentre gli affitti sono cresciuti di più del 20 per cento. In alcune capitali, come Amsterdam, Dublino o Praga, l’incremento ha superato il 100 per cento, rendendo l’accesso alla casa un miraggio per intere fasce della popolazione, dai giovani precari alle famiglie monoreddito, fino agli anziani con pensioni modeste.
Parallelamente, la domanda di abitazioni continua a crescere: si stima che ogni anno servano oltre due milioni di nuove unità abitative, soprattutto nelle aree urbane.
Eppure, i permessi di costruzione sono diminuiti di oltre il 20 per cento dal 2021, mentre gli affitti brevi – spesso legati al turismo – sono aumentati del 93 per cento tra il 2018 e il 2024, sottraendo migliaia di appartamenti al mercato residenziale.
Il risultato? Un’offerta che non tiene il passo della domanda, con effetti a catena su mobilità del lavoro, accesso all’istruzione, natalità e coesione sociale.
La casa, da diritto fondamentale, si sta trasformando in un privilegio.
Il Piano Casa europeo: obiettivi e visione
È in questo contesto che nasce il Piano Casa europeo, il primo piano strategico dell’UE dedicato all’edilizia abitativa accessibile.
L’obiettivo è chiaro: aumentare l’offerta di case accessibili, sostenibili e di qualità, intervenendo su più fronti – dalla produzione edilizia all’innovazione tecnologica, dalla semplificazione normativa agli investimenti pubblici.
La Commissione europea ha individuato quattro assi portanti:
• 1 – Aumento dell’offerta abitativa, attraverso nuove costruzioni, riuso di edifici esistenti e ristrutturazioni sostenibili.
• 2 – Innovazione e produttività nel settore delle costruzioni, con l’adozione di tecnologie avanzate e metodi moderni di costruzione (Modern Methods of Construction).
• 3 – Semplificazione normativa, per ridurre la burocrazia e velocizzare i processi di pianificazione urbana e rilascio dei titoli edilizi.
• 4 – Attivazione di investimenti pubblici e privati, anche attraverso la revisione delle norme sugli aiuti di Stato per facilitare l’edilizia sociale.
Costruire di più, costruire meglio
Per colmare il divario tra domanda e offerta, la Commissione stima che nei prossimi dieci anni sarà necessario realizzare circa 650mila abitazioni in più ogni anno, oltre alle 1,6 milioni già previste.
Un’impresa titanica, che richiederà investimenti stimati in circa 150 miliardi di euro l’anno.
Ma non si tratta solo di quantità. Il Piano punta anche alla qualità: le nuove abitazioni dovranno essere energeticamente efficienti, accessibili, integrate nel tessuto urbano e socialmente inclusive.
In quest’ottica, il riuso di edifici dismessi e la ristrutturazione del patrimonio esistente diventano strumenti chiave per rigenerare le città senza consumare nuovo suolo.
Innovazione e manodopera: le sfide del settore
Uno degli ostacoli principali alla realizzazione del Piano è la scarsa produttività del settore delle costruzioni, ancora troppo legato a metodi tradizionali e poco digitalizzati.
La Commissione intende promuovere l’adozione di tecnologie innovative – dalla prefabbricazione alla stampa 3D, dai gemelli digitali alla gestione BIM – per aumentare l’efficienza dei cantieri e ridurre tempi e costi.
Altro nodo cruciale è la carenza di manodopera qualificata. Per affrontarlo, il Piano prevede misure per migliorare l’accesso alla formazione professionale, attrarre nuovi talenti e facilitare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri.
Meno burocrazia, più case
Un altro pilastro del Piano è la semplificazione normativa.
Oggi, ottenere un permesso di costruzione può richiedere anni, tra vincoli urbanistici, codici edilizi frammentati e procedure amministrative complesse. La Commissione propone un pacchetto di semplificazioni a livello europeo e si impegna a collaborare con Stati membri, regioni e città per armonizzare e snellire le normative locali.
L’obiettivo è creare un ambiente normativo favorevole alla costruzione e alla ristrutturazione, senza compromettere la qualità, la sicurezza e la sostenibilità degli edifici.
Affitti brevi e pressione urbana
Il Piano affronta anche il tema degli affitti brevi, che in molte città europee hanno contribuito a ridurre l’offerta di alloggi a lungo termine, alimentando la speculazione e l’aumento dei prezzi.
La Commissione propone misure per regolamentare il settore, soprattutto nelle aree ad alta pressione abitativa, bilanciando le esigenze del turismo con il diritto alla casa dei residenti.
Risorse e strumenti finanziari
Per sostenere l’attuazione del Piano, la Commissione intende mobilitare una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui:
• i fondi della politica di coesione (FESR, FSE+);
• il Fondo sociale per il clima;
• InvestEU;
• il Meccanismo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
• la Banca europea per gli investimenti (BEI), che potrà svolgere un ruolo chiave nel cofinanziamento di progetti di edilizia sociale.
Inoltre, la revisione delle norme sugli aiuti di Stato consentirà agli Stati membri di sostenere più facilmente progetti di edilizia accessibile, senza incorrere in sanzioni o vincoli eccessivi.
Un’alleanza per l’abitare
Il Piano Casa europeo non è solo un documento tecnico, ma un invito alla collaborazione. La Commissione propone la creazione di un’Alleanza europea per l’edilizia abitativa accessibile, che riunisca istituzioni, enti locali, imprese, sindacati, associazioni di inquilini e società civile. L’obiettivo è condividere buone pratiche, promuovere progetti pilota e costruire una visione comune dell’abitare europeo del futuro.
Una sfida politica e culturale
Il Piano Casa europeo rappresenta un cambio di paradigma.
Per la prima volta, l’Unione europea riconosce esplicitamente l’abitare come una questione strategica, non solo sociale ma anche economica, ambientale e democratica.
Una casa dignitosa non è solo un tetto, ma una condizione essenziale per la partecipazione alla vita sociale, per l’accesso al lavoro, all’istruzione, alla salute.
La sfida è ora tradurre le intenzioni in azioni concrete, superando le resistenze burocratiche, le lentezze amministrative e le logiche speculative. Perché il diritto alla casa non resti sulla carta, ma diventi una realtà per tutti i cittadini europei.
Impianti e manutenzioni, boom di richieste. Camini e stufe a pellet protagonisti dell’inverno ‘25
- Gen 22, 2026
Con l’arrivo della stagione più fredda, l’Italia si prepara a fronteggiare l’inverno con un vero e proprio assalto ai servizi di riscaldamento domestico.
Secondo i dati di ProntoPro, tra settembre e ottobre 2025 le richieste di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti termici sono aumentate del 66 per cento, con picchi impressionanti per stufe a pellet (+72 per cento) e caminetti (+107 per cento).
Un trend che racconta molto più di una semplice reazione al calo delle temperature: è il segnale di un cambiamento culturale, energetico ed economico.
Impianti sotto stress: l’Italia corre ai ripari
Dal 15 ottobre, in molte zone climatiche italiane è possibile accendere il riscaldamento. Questo ha innescato una corsa alla revisione e all’installazione di impianti nuovi. Le caldaie, ancora largamente diffuse, registrano un aumento del 56 per cento nelle installazioni e del 66 per cento nelle manutenzioni. Il costo medio per una revisione si aggira sui 94 euro, ma può variare in base alla città e alla tipologia di impianto.
Le stufe a pellet, invece, si confermano protagoniste della transizione energetica domestica: +72 per cento di installazioni rispetto al mese precedente e +26 per cento rispetto al 2024. La manutenzione, obbligatoria per legge, ha visto un’impennata del 115 per cento, con un costo medio di 145 euro. Il pellet, combustibile a biomassa, è apprezzato per la sua efficienza e il minor impatto ambientale.
Il ritorno del camino: romanticismo e sostenibilità
Ma il vero protagonista dell’inverno 2025 è il camino.
Le richieste di installazione sono cresciute del 107 per cento rispetto a settembre e del 103 per cento rispetto al 2024. Non si tratta solo di una scelta funzionale: il camino rappresenta un ritorno al calore autentico, alla convivialità, alla tradizione. A Roma e Napoli, oltre il 92 per cento dei camini e delle stufe è alimentato a legna, mentre a Milano si affermano i camini a gas (8 per cento) e le stufe a pellet (11 per cento).
Spazzacamini in prima linea: sicurezza e prevenzione
Con l’aumento dei camini e delle stufe, cresce anche la domanda di spazzacamini: +65 per cento tra settembre e ottobre, +72 per cento rispetto al 2024. La pulizia della canna fumaria è fondamentale per evitare incendi e garantire l’efficienza dell’impianto. Il costo medio nazionale è di 155 euro, ma Venezia guida la classifica con 178€ a intervento, mentre Bari e Napoli sono le più economiche (120 euro e 122 euro).
Il servizio è richiesto soprattutto per impianti a legna (86 per cento), seguiti da quelli a pellet (13 per cento). La figura dello spazzacamino, un tempo quasi folkloristica, oggi è sinonimo di sicurezza domestica e rispetto delle normative.
Manutenzione obbligatoria: tra legge e buon senso
Secondo il D.P.R. 74/2013, ogni impianto termico deve essere sottoposto a controlli periodici. La frequenza varia in base al tipo di combustibile e alla potenza dell’impianto. La mancata revisione può comportare sanzioni fino a 500 euro, oltre a rischi per la sicurezza e sprechi energetici.
Le motivazioni principali per richiedere interventi sono:
• Revisione annuale (42 per cento);
• Controllo dei fumi (19 per cento);
• Manutenzione ordinaria (18 per cento).
Una manutenzione tempestiva consente di evitare guasti, ridurre i consumi e limitare l’impatto ambientale.
Riscaldarsi in modo sostenibile: consigli pratici
Secondo Consumerismo, adottare buone abitudini può ridurre i consumi fino al 30 per cento:
• Impostare la temperatura tra 19°C e 21°C;
• Usare termostati programmabili;
• Isolare porte e finestre;
• Effettuare controlli prima dell’accensione.
Inoltre, scegliere impianti a biomassa o pompe di calore può contribuire alla decarbonizzazione del settore domestico, in linea con gli obiettivi europei.
Italia divisa: le città e le loro preferenze
Le abitudini variano notevolmente da città a città:
• Milano: predilige pellet e gas;
• Roma e Napoli: fedeli alla legna;
• Venezia: la più cara per la pulizia delle canne fumarie;
• Bari e Napoli: le più convenienti.
Queste differenze riflettono non solo il clima, ma anche la cultura, l’urbanistica e la disponibilità di risorse locali.
Un mercato in espansione
Il settore del riscaldamento domestico si conferma in forte espansione. Secondo gli esperti, la crescita continuerà nei prossimi anni, spinta da:
• Incentivi per la riqualificazione energetica;
• Aumento dei costi dell’energia;
• Maggiore consapevolezza ambientale.
Le aziende del settore stanno investendo in tecnologie più efficienti, come caldaie ibride, sistemi domotici e impianti integrati.
Il calore come scelta consapevole
Il freddo non è solo una condizione climatica, ma un’occasione per riflettere su come ci riscaldiamo. Le scelte degli italiani raccontano un Paese che riscopre il valore del comfort, della sicurezza e della sostenibilità. Che si tratti di un camino acceso o di una caldaia revisionata, ogni gesto è un passo verso un inverno più caldo, sicuro e responsabile.
Teleriscaldamento, Arera proroga fino al 2026 le tariffe transitorie
- Gen 22, 2026
Con una decisione definita “indifferibile e urgente”, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il regime transitorio delle tariffe per il teleriscaldamento.
La delibera 580/2025/R/tlr, approvata il 23 dicembre, estende di fatto il periodo di “ponte” in attesa di un metodo tariffario definitivo.
Una scelta che punta a garantire stabilità economica e continuità del servizio in un momento delicato, segnato anche dalla fine del mandato dell’attuale Collegio dell’Autorità.
Ma attenzione: non si tratta solo di una proroga tecnica.
Arera ha colto l’occasione per introdurre correttivi importanti, destinati ad avere un impatto diretto sulle bollette e sulla gestione degli impianti, soprattutto nei contesti condominiali.
Tariffe più eque e flessibili: cosa cambia per gli operatori (e per gli utenti)
Uno dei nodi principali riguarda la sostenibilità economica del servizio.
Per le reti di teleriscaldamento attive già prima dell’entrata in vigore della regolazione, sarà ora possibile rivedere il coefficiente di riduzione delle tariffe.
In pratica, se un gestore dimostra che le attuali regole non coprono i costi strutturali del servizio, potrà chiedere un adeguamento.
Questo significa maggiore flessibilità per gli operatori, ma anche una maggiore probabilità che i costi vengano redistribuiti sugli utenti finali.
Per chi vive in un condominio servito dal teleriscaldamento, questo si traduce in una maggiore attenzione ai bilanci degli operatori e nella possibilità di variazioni tariffarie più frequenti, ma anche più trasparenti.
Controlli trimestrali e conguagli più leggeri
Un’altra novità riguarda la gestione dei costi di approvvigionamento del calore. Se un gestore acquista energia termica da terzi a prezzi elevati – e non ha legami societari con il fornitore – potrà chiedere ad Arera di rivedere il tetto massimo ai ricavi.
Questo meccanismo tutela gli operatori da squilibri economici, ma introduce anche un nuovo sistema di controlli: ogni tre mesi, saranno effettuate verifiche sui ricavi effettivi, con la possibilità di adeguare le tariffe in corso d’anno attraverso una componente specifica, chiamata “sigma”.
Per gli utenti, questo significa meno sorprese in bolletta: i conguagli annuali saranno più contenuti, grazie a un monitoraggio continuo e a correzioni tempestive.
Più incentivi per chi investe in reti efficienti
Il provvedimento guarda anche al futuro, con un occhio alla sostenibilità.
Le reti che rispettano i criteri europei di “teleriscaldamento efficiente” potranno aumentare le tariffe fino al 2 per cento rispetto al vincolo regolatorio, ma solo se oggi applicano prezzi inferiori.
L’obiettivo è chiaro: incentivare gli investimenti in tecnologie più pulite e contribuire alla decarbonizzazione del settore.
Per i condomìni serviti da queste reti, l’aumento sarà contenuto, ma giustificato da un miglioramento dell’efficienza e da un minore impatto ambientale. Un’opportunità, quindi, per chi vuole coniugare comfort abitativo e responsabilità ecologica.
Più trasparenza per tutti
Infine, Arera ha rafforzato gli obblighi di trasparenza per gli operatori.
I gestori dovranno comunicare con maggiore precisione i dati tecnici ed economici, inclusi i fattori di emissione e i costi evitati.
Queste informazioni saranno fondamentali per calcolare le tariffe e per garantire che gli utenti – proprietari, inquilini e amministratori – possano comprendere meglio cosa pagano e perché.
In un momento in cui l’energia è al centro delle scelte economiche e ambientali di ogni famiglia, la chiarezza diventa un diritto.
E questa riforma, pur transitoria, rappresenta un passo avanti verso un sistema più equo, sostenibile e comprensibile per tutti.