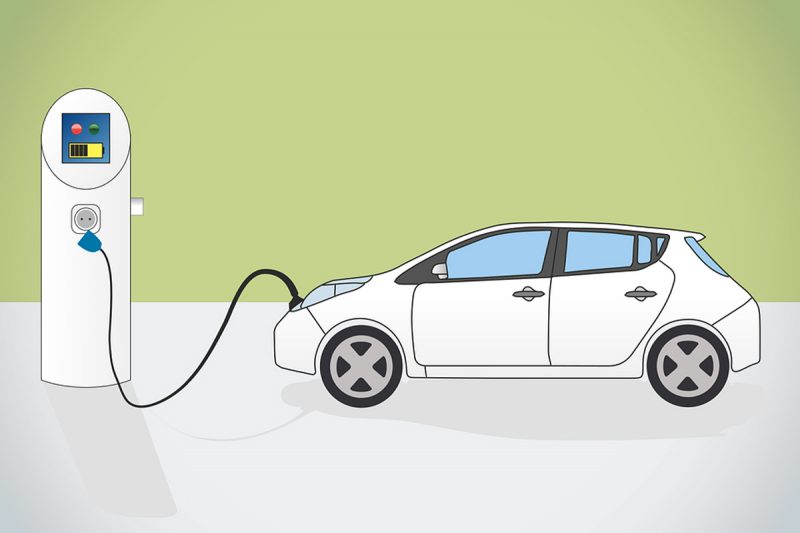ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
Anno 2025, quanto costa mantenere una casa?
Possedere una casa in Italia è un investimento che va ben oltre il prezzo d’acquisto. Nel 2025, il costo medio per la gestione di un’abitazione si attesta a 1.298 euro al mese, pari a oltre 15.500 euro l’anno.
Tuttavia, le differenze territoriali sono significative: vivere in una grande città del Nord può costare fino al 47 per cento in più rispetto al Sud e alle Isole.
Le città più costose: Milano in testa, Palermo la più economica
Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, Milano si conferma la città più cara: mantenere un’abitazione di 100 mq in zona semicentrale costa in media oltre 2mila euro al mese. Al contrario, Palermo è la città più economica, con una spesa mensile di 707 euro, seguita da Bari e Cagliari.
Tra le città più costose troviamo anche Roma, che si posiziona al secondo posto con 1.752 euro al mese, seguita da Firenze (1.356 euro) e Bologna (1.372 euro).
Il mutuo: la voce di spesa più pesante
La rata del mutuo è il fattore che incide maggiormente sul bilancio familiare, arrivando a rappresentare fino all’86 per cento della spesa mensile.
• Milano: rata media di 1.700 euro per un immobile dal valore di 465.000 euro.
• Roma: rata di 1.500 euro per un immobile da 410.000 euro.
• Firenze e Bologna: rispettivamente 1.102 euro e 1.080 euro al mese.
• Palermo e Bari: cifre più contenute, con 489 euro e 619 euro di rata mensile.
Anche optando per l’ affitto, i costi non calano drasticamente: secondo i dati OMI, la riduzione media è solo del 6 per cento rispetto al mutuo.
Utenze e manutenzione: il Nord spende di più
Le spese per luce, gas, acqua e manutenzione ordinaria variano sensibilmente tra le diverse aree del Paese. Al Nord, si spende in media il 29 per cento in più rispetto al Centro e il 48 per cento in più rispetto al Sud.
• Milano: quasi 300 euro al mese per utenze e manutenzione.
• Torino e Genova: rispettivamente 288 euro e 284 euro.
• Cagliari, Palermo e Bari: le città più economiche, con 175 euro, 190 euro e 195 euro al mese.
Il clima più mite nelle regioni meridionali contribuisce a contenere i consumi energetici, soprattutto per il riscaldamento.
La Tari: il Sud paga di più
L’unica voce di spesa che ribalta il trend Nord-Sud è la Tari, la tassa sui rifiuti. In media, le famiglie del Mezzogiorno spendono il 16 per cento in più rispetto a quelle del Nord.
• Genova: la città con la Tari più alta, 501 euro all’anno.
• Napoli e Cagliari: rispettivamente 482 euro e 465 euro.
• Bologna, Milano e Roma: le città con la Tari più contenuta, rispettivamente 287 euro, 316 euro e 394 euro.
Mantenere una casa: un impegno economico significativo
Il 2025 conferma che mantenere una casa in Italia è un impegno economico rilevante, con costi che variano notevolmente in base alla città e alla zona geografica.
Chi vive nelle grandi città del Nord deve affrontare spese più elevate, mentre il Sud offre costi più contenuti, seppur con una Tari più alta. La rata del mutuo resta la voce di spesa più pesante, seguita dalle utenze e dalla manutenzione.
Per chi sta valutando l’acquisto di una casa, è fondamentale considerare non solo il prezzo dell’immobile, ma anche i costi di gestione e mantenimento, che possono incidere fortemente sul bilancio familiare.
Le detrazioni per la sostituzione degli infissi
- Set 25, 2025
Devo sostituire i serramenti della prima casa, senza ristrutturazione e senza pratica edilizia. Oltre al nuovo tetto sulla spesa detraibile, nel 2025 restano i bonus al 50 per cento?
La Legge di Bilancio 2025 riduce l’aliquota delle detrazioni edilizie ma resta il 50 per cento se i lavori riguardano la prima casa, sia per le ristrutturazioni sia per le riqualificazioni. Ma con nuove soglie di spesa detraibile per alcuni contribuenti.
Nel solo caso dei lavori sull’abitazione principale, anche nel 2025 la detrazione è al 50 per cento, con tetto di spesa o limite di detrazione invariati. Per le altre tipologie di immobili, invece, la detrazione scende al 36 per cento.
La sostituzione dei serramenti può essere agevolata sia con il bonus ristrutturazioni, al 50 per cento fino a un tetto di spesa di 96mila euro, sai con l’agevolazione sulle ristrutturazioni energetiche, con la stessa aliquota e con tetto alla detrazione pari a 60mila euro.
Tuttavia, per contribuenti con reddito superiore a 75mila euro, dall’anno fiscale 2025 scatta un tetto massimo applicabile alle spese ammesse alle detrazioni. Questo limite è pari a 14mila euro e scende a 8mila euro per chi guadagna più di 100mila euro. Vanno anche applicati coefficienti relativi alla presenza di figli nel nucleo familiare, per cui in assenza di figli il tetto massimo si abbassa.
Per riassumere, lei potrà applicare nel 2025 la detrazione al 50 per cento per la sostituzione degli infissi ma, se il suo reddito è superiore a 75mila euro, dovrà verificare di non sforare il tetto massimo di spesa detraibile applicabile al suo nucleo familiare, valutando le altre spese detraibili che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia.
Efficienza energetica, meno burocrazia e più fondi: ecco il nuovo Conto Termico
- Set 24, 2025
Il Conto Termico 3.0 è realtà. Con l’approvazione del decreto da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Italia compie un passo deciso verso la transizione energetica, semplificando l’accesso agli incentivi e ampliando la platea dei beneficiari.
Il nuovo meccanismo, che mette a disposizione fino a 900 milioni di euro l’anno, si propone di rilanciare gli investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili, soprattutto in un momento in cui il settore edilizio cerca nuove leve di sviluppo dopo la rimodulazione dei bonus tradizionali.
La novità più significativa riguarda l’apertura agli edifici non residenziali privati, finora esclusi dal perimetro degli interventi incentivabili.
Uffici, negozi, strutture del terziario potranno ora accedere al contributo, a patto che gli interventi rispettino i requisiti tecnici e siano realizzati da installatori qualificati.
A beneficiarne saranno anche gli enti del Terzo Settore, equiparati alle pubbliche amministrazioni, e le Comunità Energetiche Rinnovabili, che potranno accedere agli incentivi attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo.
Sul fronte tecnologico, il decreto introduce nuove tipologie di intervento: impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore.
Una scelta che punta a favorire l’elettrificazione dei consumi e a integrare produzione, accumulo e mobilità sostenibile in un’unica strategia di efficientamento.
La copertura dei costi è stata potenziata: fino al 65 per cento per soggetti privati e fino al 100 per cento per interventi su edifici pubblici situati in comuni con meno di 15mila abitanti, scuole, ospedali e strutture sanitarie.
I massimali di spesa sono stati aggiornati per riflettere l’aumento dei costi di mercato, con valori differenziati in base al tipo di intervento e al soggetto beneficiario.
Per i professionisti del settore costruzioni, il Conto Termico 3.0 rappresenta una vera e propria svolta.
Progettisti, ingegneri, energy manager e consulenti CER potranno contare su una domanda crescente di consulenza e progettazione, soprattutto in ambiti come impianti termici, fotovoltaico e sistemi di building automation.
La semplificazione burocratica e la possibilità di accedere agli incentivi anche tramite prenotazione (per la PA) o accesso diretto (per privati e PA) rendono il meccanismo più snello e attrattivo.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) avrà il compito di aggiornare il portale informatico entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dando così il via alla fase operativa.
La procedura prevede la presentazione online dell’istanza, corredata da documentazione tecnica, attestazione di fine lavori, fatture, bonifici parlanti e, ove previsto, l’Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento.
In un contesto in cui la Direttiva Case Green impone obiettivi stringenti di riduzione delle emissioni, il Conto Termico 3.0 si configura come uno strumento strategico per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche.
Non si tratta di una detrazione fiscale da recuperare in anni, ma di un contributo diretto, erogato in contanti dal GSE, che può arrivare in un’unica soluzione per importi fino a 15mila euro.
Il messaggio è chiaro: la transizione energetica non è più un’opzione, ma una necessità.
E con il Conto Termico 3.0, il governo italiano offre una leva concreta per accelerare il cambiamento, rendendo più semplice, accessibile ed efficace il percorso verso edifici più sostenibili, efficienti e autonomi.
Cattiva gestione dell’amministratore di condominio e possibili conseguenze
- Set 23, 2025
La gestione di un condominio è indubbiamente un compito complesso che un amministratore deve essere in grado di portare avanti con serietà e professionalità. Difatti, l’attività dell’amministratore di condominio comprende vari aspetti e responsabilità, da quello relativo alla gestione contabile, a quello relativo al rispetto delle norme o al recupero crediti in caso di condòmini morosi. Un amministratore di condominio professionale deve essere in grado di fronteggiare ogni tipo di situazione, così come deve rendere conto del proprio operato e garantire che ogni decisione venga presa nel rispetto delle regole e nell’interesse collettivo.
Proprio per questi motivi, da un punto di vista giuridico l’amministratore di condominio ha delle precise responsabilità sia di tipo civile che di tipo penale. La responsabilità civile si divide in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
La responsabilità contrattuale riguarda i rapporti tra privati che hanno assunto obbligazioni regolate da un contratto, regolata dall’art. 1218 c.c. secondo cui “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
La responsabilità extracontrattuale si riferisce, in linea generale, alla mancata osservanza di norme civili che prescrivono la tenuta di determinati comportamenti ed è regolata dall’art. 2043 c.c. secondo cui: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità penale questa deriva da un’azione o da un’omissione di natura dolosa o colposa che costituisce un reato secondo il codice penale.
Tra gli obblighi di un amministratore di condominio, i più importanti sono:
• curare l’osservanza del regolamento condominiale;
• eseguire le delibere assembleari e provvedere alla convocazione dell’assemblea almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
• verificare la regolarità della contabilità condominiale, tenendo i relativi registri e provvedendo ai vari adempimenti fiscali;
• regolare l’uso e il godimento delle parti comuni e riscuotere i contributi per provvedere alle spese di manutenzione;
• fornire ai condòmini i documenti richiesti;
• tenere i registri di anagrafe condominiale e quelli di nomina e revoca degli amministratori;
• aprire un conto corrente intestato al condominio
• conservare tutta la documentazione inerente alla sua gestione del condominio.
La mancata osservanza di questi obblighi comporta la responsabilità dell’amministratore in ambito civile ed è proprio quando l’amministratore non adempie a questo tipo di doveri che si parla di “mala gestio”, ovvero la cattiva gestione condominiale.
Quando si parla di mala gestio dell’amministratore, infatti, si fa riferimento a una cattiva gestione di tale ruolo, tale da poter causare un danno economico al condominio. Difatti, se un amministratore ha una gestione negligente, non trasparente e non adatta a curare gli interessi del bene amministrato e dei condòmini, il condominio può ritrovarsi a dover affrontare problemi legati a bilanci poco chiari, carenza di manutenzione, spese ingiustificate e difficoltà nel recupero delle morosità.
Di fronte a queste spiacevoli situazioni i condòmini possono agire chiedendo la revoca dell’incarico, così come stabilito dalla Legge n. 220 del 2012 che per contrastare questi comportamenti negligenti ha introdotto la possibilità di revocare l’incarico all’amministratore in presenza di gravi irregolarità.
Nel caso in cui dopo la revoca si scoprisse che l’ex amministratore ha omesso informazioni importanti o ha causato danni economici al condominio, i condòmini hanno diritto a chiedere chiarimenti, sollecitare eventuali interventi e avviare un procedimento legale per chiedere il risarcimento dei danni.
Naturalmente, per ottenere un risarcimento è necessario che vi siano prove solide riguardo alla negligenza con cui ha operato l’amministratore causando di conseguenza dei danni al condominio, ciò significa che per chiedere un risarcimento dei danni è necessario che vi siano documenti, relazioni tecniche o testimonianze che attestino che il condominio ha subito danni reali proprio a causa di comportamenti scorretti attuati dall’amministratore.
Nei casi più gravi, come ad esempio l’appropriazione indebita di denaro, è possibile anche arrivare ad un procedimento di tipo penale.
Tra le situazioni più diffuse di mala gestio dell’amministratore vi sono:
• l’atteggiamento di inerzia nel recupero crediti nei confronti dei condòmini morosi, poiché chiaramente se alcuni condòmini non pagano e l’amministratore non si attiva per recuperare le somme dovute ciò ricade su tutto il condominio;
• la mancata apertura di un conto corrente condominiale, visto che per legge tutte le somme che riguardano il condominio devono transitare su un conto corrente intestato al condominio stesso;
• assenza dei rendiconti e gestione della contabilità non trasparente, quindi non supportata da idonea documentazione;
• utilizzo improprio delle somme di denaro condominiali, perciò qualsiasi spesa effettuata senza autorizzazione o qualsiasi prelievo di denaro non giustificato.
Dati tutti i rischi citati, è bene, quindi, ricordare che quando si gestisce un condominio l’amministratore ha il dovere di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia, pertanto impegnandosi adeguatamente per soddisfare gli interessi del condominio.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Portiere del condominio: la gestione delle ferie e dei permessi non goduti
- Set 22, 2025
Il portiere di un condominio ha – al 31 dicembre 2023 – 12 giorni di ferie residue. Per il 2024 ha chiesto ferie per 24 giorni. L’amministratore condominiale può esigere, o in qualche modo ottenere, di fargli smaltire le vecchie ferie e fargli prendere in ogni anno di riferimento tutte le ferie maturate? Per quanto concerne i permessi, poi, lo stesso amministratore può esigere, o in qualche modo ottenere, che siano fruiti per intero durante l’anno di maturazione?
Secondo quanto previsto dal titolo V, capo II, dell’articolo 82 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) per i dipendenti da proprietari di fabbricati, il datore di lavoro ha facoltà di assegnare al lavoratore il restante periodo di ferie non optato dal lavoratore.
Quindi, gestendo le ferie in base alle disposizioni contrattuali, si eviterebbe di accumulare residui di ferie.
Per esercitare tale facoltà, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al dipendente la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Tale comunicazione scritta dovrà avere luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso.
Inoltre, il Ccnl precisa che, salvi diversi accordi, la scelta di tale periodo, frazionabile in non più di due tranche, sarà fatta dal datore di lavoro, sentito il lavoratore.
Va infine considerato che, in genere, i datori di lavoro sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, nei periodi più confacenti al lavoratore, fatte salve condizioni di miglior favore.
Per quanto concerne i permessi, l’articolo 84 del Ccnl stabilisce che quelli non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria.
Solo se si intende derogare a questo principio, con l’accordo delle parti, è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell’anno con quelli dell’anno successivo.
In condominio le colonnine di ricarica elettrica sono considerate intervento straordinario
- Set 19, 2025
L’evoluzione del mercato automobilistico, nel nome della riduzione delle emissioni di CO2, sta progressivamente diffondendo l’utilizzo di veicoli elettrici.
È pertanto in crescita la necessità di installare colonnine elettriche per la ricarica di auto anche nei condomìni.
Ma non è semplice realizzare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in stabili multifamiliari o condominiali, a causa della loro struttura proprietaria, che spesso rende il processo decisionale più complesso a causa di innumerevoli problematiche: costi elevati, mancanza di spazio, inadeguatezza dell’impianto elettrico esistente, mancanza di consenso degli altri proprietari, ambienti e impianti non a norma per ottenere l’autorizzazione.
Il tema abbraccia inoltre diversi aspetti giuridici legati principalmente alle proprietà comuni ed esclusive, alle necessità di autorizzazione e ai quorum assembleari richiesti.
Innovazione e manutenzione straordinaria
L’installazione delle colonnine elettriche rientra nel novero delle manutenzioni straordinarie.
L’articolo 1135 del Codice civile impone per queste opere l’obbligatoria costituzione del fondo speciale.
L’assemblea dovrà deliberare la costituzione di un fondo speciale in mancanza del quale la decisione sarà viziata da nullità.
Alle colonnine elettriche si applicano i divieti previsti per le innovazioni condominiali, per tali dovendosi intendere le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni.
Le colonnine elettriche in condominio sono vietate se arrecano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, alterano il decoro architettonico o rendono alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino.
Per quanto attiene al limite della sicurezza dell’edificio, l’installazione di una colonnina per le auto elettriche dovrà essere curata da un tecnico specializzato in grado di rilasciare il certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento.
Il quorum deliberativo
L’articolo 17-quinquies del decreto legge 83/2012 dispone che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in condominio devono essere approvate dall’assemblea in seconda convocazione con la maggioranza espressa dall’articolo 1136, comma 3, Codice civile.
È sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, il condòmino potrà installare le colonnine elettriche a proprie spese.
Gli altri condòmini potranno partecipare successivamente ai vantaggi dell’innovazione, concorrendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.
L’installazione nel proprio box
Nel caso di impianto esclusivo all’interno dell’autorimessa privata, se l’installazione riguarda solo la propria unità immobiliare senza influire sulle parti comuni o sulla sicurezza del complesso, non sarà necessario premunirsi di autorizzazione assembleare.
Tuttavia, il condòmino sarà tenuto a informare l’amministratore, il quale dovrà garantire che l’intervento osserva le norme tecniche di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Una volta deliberata l’installazione, è necessario stabilire le modalità di utilizzo delle colonnine elettriche.
Nessuna difficoltà se sono sufficienti per tutti i condòmini. Se, invece, il numero è insufficiente o se il loro utilizzo contemporaneo comporti sovraccarichi, sarà necessario prevedere turnazioni individuando un criterio di imputazione dei costi della ricarica che l’amministratore addebiterà agli utilizzatori.
Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali
- Set 16, 2025
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da una contribuente attraverso la “Posta di FiscoOggi”, ha affrontato la tematica relativa alle possibili agevolazioni per la sostituzione dei condizionatori.
Nello specifico, la contribuente si è rivolta al Fisco spiegando che vorrebbe sostituire il condizionatore con uno a più basso consumo energetico, ma il dubbio posto è quello inerente alla possibile fruizione di agevolazioni fiscali, anche in assenza di ulteriori lavori.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici è disciplinata dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 e dall’articolo 16-bis, lett. h) del TUIR, ai sensi del quale questo tipo di interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo comunque l’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Il Fisco chiarisce che la Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) all’art. 1, comma 55, ha stabilito che tale detrazione spetta anche per le spese documentate e sostenute nel 2025, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa del 36% delle spese sostenute.
La detrazione sale al 50% delle spese sostenute nel caso in cui queste siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, quindi, la detrazione fiscale spettante per il 2025 è pari al 50% per interventi come la sostituzione del climatizzatore con uno più efficiente, sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre è pari al 36% per le abitazioni non principali.
Per quanto concerne gli anni 2026 e 2027 la detrazione fiscale spettante per questa tipologia di interventi scenderà al 36% per le abitazioni principali e al 30% per le altre tipologie di immobili.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per poter fruire dell’agevolazione è necessario che i pagamenti vengano effettuati attraverso bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) e il numero e la data della fattura a cui si riferisce il bonifico.
A tal proposito ricordiamo che è importante anche conservare le varie fatture e l’eventuale documentazione amministrativa inerente all’intervento effettuato, così da poterla esibire in caso di controlli da parte del Fisco.
A cura di Deborah Foti – Ufficio stampa Anapi
Supercondominio e spese per le canne fumarie
- Set 16, 2025
Nel nostro supercondominio devono essere eseguiti interventi sulle canne fumarie, per il loro adeguamento alle normative vigenti. Si tratta di un supercondominio con diversi numeri civici e le canne fumarie servono i vari condomìni in misura diversa (più canne fumarie per ogni numero civico). Come devono essere ripartite le spese di ristrutturazione per l’adeguamento delle singole canne fumarie?
Fermo restando un diverso criterio di riparto eventualmente previsto nel regolamento di condominio, nel caso prospettato deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile.
In base a tale disposizione codicistica, qualora un edificio – nel caso in esame, il supercondominio – abbia beni o servizi che per sue caratteristiche intrinseche o per funzione siano destinati a servire una parte sola di condòmini, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Questi beni o servizi rimangono oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una titolarità condivisa di tutti su quello stesso bene (Corte di Cassazione, sentenza n. 12641 del 2016).
Mancano, in questi casi, i presupposti per definire quei beni come “parti comuni dell’edificio” a norma dell’articolo 1117 del Codice civile, dato che essi sono destinati all’uso o al servizio non di tutto il condominio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso.
In questo caso si configura automaticamente il condominio parziale, che non ha bisogno di alcun atto costitutivo.
Si modifica, quindi, la composizione del collegio e delle maggioranze: il gruppo di condòmini che esercita una titolarità su quei beni e/o servizi rientranti nel condominio parziale ha un peso differente nella formazione della maggioranza rispetto al gruppo di condòmini che non ha la titolarità su quei beni e/o servizi.
Le spese necessarie per l’adeguamento delle canne fumarie in questione devono, dunque, restare a carico del gruppo di condòmini che ne trae diretto beneficio.
Bonus prima casa, più tempo per vendere l’immobile
- Set 15, 2025
Buone notizie per chi ha beneficiato del bonus prima casa: la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una proroga per la vendita dell’immobile, che consente ai proprietari di conservare le agevolazioni anche se hanno acquistato prima dell’inizio di quest’anno.
Grazie alla nuova norma sarà possibile vendere l’abitazione entro due anni, anziché uno, a patto che il termine precedente non sia già scaduto al 31 dicembre 2024.
A chiarire la portata di questa estensione è stata l’Agenzia delle Entrate, nell’Interpello numero 127 del 2025.
Più tempo per vendere e mantenere le agevolazioni
Il provvedimento modifica le scadenze previste dall’articolo 1, nota II-bis, comma 4-bis della Tariffa allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (TUR), ridefinendo i tempi a disposizione dei contribuenti per la vendita del loro immobile senza perdere le agevolazioni fiscali.
Grazie alla proroga introdotta dalla Legge di Bilancio, chi ha già usufruito del bonus può accedere nuovamente all’agevolazione, versando l’imposta di registro al 2 per cento anche per un nuovo acquisto. Tuttavia, affinché il beneficio rimanga valido, la casa acquistata in precedenza deve essere venduta entro il termine dei due anni.
Ma la novità più interessante è che la proroga non riguarda solo gli acquisti effettuati dal 2025 in poi: la nuova finestra temporale ha effetto retroattivo, consentendo di procedere con la vendita entro 24 mesi anche a chi ha comprato casa prima di quest’anno, purché il termine di un anno non sia già scaduto al 31 dicembre 2024.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
L’estensione dei tempi di vendita è stata confermata anche in un caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello numero 127 del 5 maggio 2025.
Nel quesito, un contribuente che aveva effettuato il secondo acquisto con l’agevolazione prima casa il 25 gennaio 2024 ha chiesto chiarimenti sui termini di vendita della prima abitazione. Grazie alle nuove disposizioni, avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per completare l’operazione senza perdere il bonus.
Questo chiarimento conferma che la proroga non si applica solo ai nuovi acquirenti, ma riguarda anche chi ha acquistato casa negli anni precedenti, offrendo maggiore flessibilità per chi deve vendere il proprio immobile.
Una misura vantaggiosa
L’estensione dei termini per la vendita degli immobili acquistati con il bonus prima casa rappresenta un importante vantaggio per i proprietari, dando loro più tempo per gestire la transazione e conservare le agevolazioni fiscali, evitando le pressioni della scadenza originaria di 12 mesi.
La misura offre quindi maggior respiro ai contribuenti e facilita la gestione degli investimenti immobiliari, assicurando più flessibilità nel mercato della compravendita.
Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro sostenibile
- Set 12, 2025
Le forme aggregative per la produzione e l’autoconsumo dell’energia da fonti rinnovabili rappresentano un’opportunità unica per affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo.
Consentono infatti di sostenere i redditi più deboli, ridurre i costi energetici e contribuire alla transizione ecologica, offrendo un supporto tangibile per il raggiungimento dell’obiettivo “immissioni zero” entro le scadenze fissate dalle politiche europee sul clima.
Per incentivare il più possibile la loro costituzione, la scadenza per i Comuni con meno di 5mila abitanti di presentare richieste di contributi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), le Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER) e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili è stata prorogata dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025.
Questa proroga, stabilita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il DM 59/2025, nasce dall’esigenza di incentivare un maggiore numero di domande, dato che le risorse disponibili non sono state completamente utilizzate.
Parallelamente, il MASE ha avviato colloqui con la Commissione Europea per valutare ulteriori potenziamenti delle misure, di cui questa proroga rappresenta solo il primo passo.
Invio delle richieste e incentivi disponibili
Dall’8 aprile 2024 i piccoli Comuni hanno potuto presentare, attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), richieste per accedere agli incentivi destinati alle CER e alle configurazioni di autoconsumo. Questi incentivi sono disciplinati dal DM 414 del 7 dicembre 2023 e dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) emanato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Le richieste possono riguardare impianti fotovoltaici già in funzione o a progetto.
Per questi ultimi, è possibile richiedere una verifica preliminare per accertarne l’idoneità al meccanismo di autoconsumo diffuso. Gli strumenti di supporto del GSE, come la “Guida all’applicazione SPC” e le Guide Interattive, semplificano la compilazione e l’invio delle richieste.
Contributi a fondo perduto: investimenti e PNRR
Per gli impianti a fonti rinnovabili e i relativi potenziamenti inseriti in configurazioni CER o CACER nei piccoli Comuni, il MASE ha pubblicato ad aprile 2024 un Avviso per i contributi in conto capitale, finanziato con 2,2 miliardi di euro dal PNRR nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.
Questi contributi coprono fino al 40 per cento dei costi iniziali, con particolare attenzione ai Comuni sotto i 5mila abitanti.
Le richieste devono essere presentate tramite il Portale del GSE, seguendo le regole operative allegate al DM 22 del 23 febbraio 2024. La finestra di candidatura, inizialmente fissata al 31 marzo 2025, è stata prorogata al 30 novembre 2025, consentendo una maggiore partecipazione per accedere ai fondi rimanenti.
Supporto per consumatori e simulatore del GSE
Il GSE ha lanciato un simulatore online per aiutare piccole e medie imprese, pubblica amministrazione, gruppi di autoconsumatori e singoli cittadini interessati a installare impianti fotovoltaici a stimare i benefici economici e ambientali dell’autoconsumo.
Questo strumento, disponibile sul Portale autoconsumo fotovoltaico, consente simulazioni tecnico-economiche dettagliate.
Il supporto si estende anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ampliando le opzioni per i consumatori.
Verso una transizione energetica partecipata
Secondo il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, “le CER rappresentano una svolta epocale: persone e territori diventano protagonisti delle scelte energetiche, affrontando anche problemi come lo spopolamento dei piccoli Comuni”.
Vinicio Vigilante, Amministratore delegato del GSE, ha sottolineato che le CER portano a un nuovo modello di condivisione dell’energia, trasformando il consumatore in un partecipante attivo del sistema energetico.
Paolo Arrigoni, Presidente del GSE, ha aggiunto che la configurazione delle CER e dell’autoconsumo diffuso stimola famiglie, imprese e pubblica amministrazione a utilizzare l’energia in modo più consapevole ed efficiente, consolidando i pilastri di una transizione energetica inclusiva e sostenibile
Autoconsumo collettivo e comunità energetiche
Tra le soluzioni emergenti, spiccano i gruppi di autoconsumo collettivo (AUC) e le comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sebbene entrambi i modelli mirino a ottimizzare l’uso dell’energia rinnovabile locale, si differenziano per configurazione e ambito applicativo:
• Gli AUC si limitano a un singolo edificio o complesso con più utenze, come condomini o strutture aziendali;
• Le CER, invece, aggregano utenti distribuiti su un’area geografica più ampia e necessitano della creazione di una struttura giuridica specifica per coordinare la produzione e la condivisione di energia.
Grazie agli impianti fotovoltaici e ad altre soluzioni basate su fonti rinnovabili, gli AUC e le CER permettono di:
• Ridurre la dipendenza energetica dalla rete nazionale.
• Aumentare l’autonomia energetica e garantire maggiore stabilità nei costi.
• Promuovere un consumo più sostenibile e efficiente, diminuendo lo spreco di risorse e migliorando la resilienza locale alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.
Il ruolo del “prosumer” e dell’autonomia energetica
Elemento chiave di entrambi i modelli è la figura del “prosumer” (producer + consumer), ovvero un soggetto che produce e consuma energia. Questo nuovo ruolo segna una rivoluzione nel settore energetico, trasformando i consumatori in attori attivi e consapevoli, capaci di gestire l’energia prodotta autonomamente e contribuire direttamente alla sostenibilità ambientale.
Oltre la sostenibilità: vantaggi economici e sociali
La realizzazione di AUC e CER non comporta solo benefici ambientali, ma offre un valore aggiunto economico e sociale.
Tra i principali vantaggi si possono citare:
• Riduzione delle bollette energetiche, un aspetto particolarmente rilevante in un contesto di povertà energetica che colpisce fasce sempre più ampie della popolazione;
• Maggiore coesione sociale, con la creazione di reti collaborative tra famiglie, imprese e istituzioni locali;
• Sostegno all’economia locale, grazie all’utilizzo di energia prodotta “a chilometro zero” e agli investimenti in tecnologie innovative.
Un futuro energetico decentralizzato
L’adozione di queste soluzioni rappresenta un passo importante verso un modello energetico decentralizzato, dove la produzione di energia avviene vicino al punto di consumo.
Questo approccio riduce le perdite di trasmissione, minimizza l’impatto ambientale e migliora la resilienza complessiva del sistema energetico.
Inoltre, grazie a incentivi governativi e programmi di supporto come quelli previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la transizione verso AUC e CER è sempre più accessibile e sostenibile.
Promuovere e diffondere questi modelli non solo significa abbattere le emissioni di CO2, ma anche costruire comunità più solide, inclusive e orientate al futuro.
Gli AUC e le CER incarnano il passaggio da un consumo individualista a un sistema basato su responsabilità condivisa e collaborazione per il bene comune.